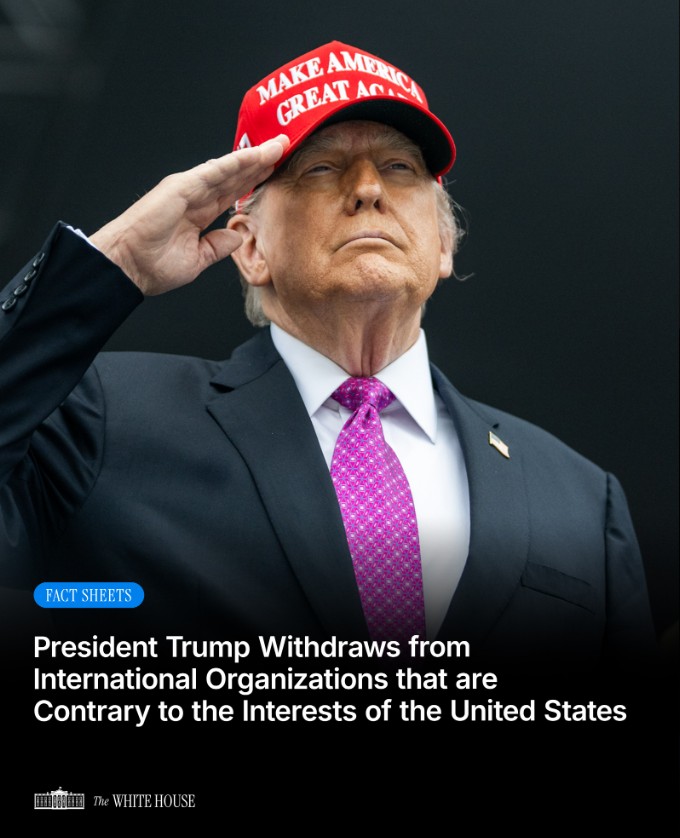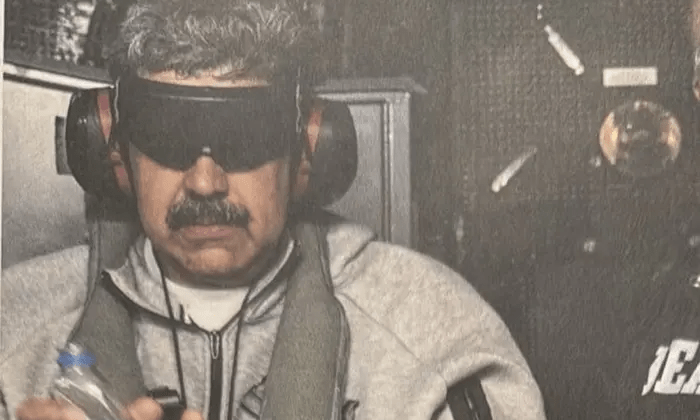Donald Trump ha firmato mercoledì 7 gennaio un memorandum per ritirare gli Stati Uniti dalla Convenzione quadro Onu sul cambiamento climatico, la cosiddetta Unfccc, e dal panel Ipcc. Bye bye, dunque? In realtà solo dal secondo, come spiega Jacopo Bencini di Italian climate network. Per uscire dal primo serve un’autorizzazione del Congresso, che al momento non ha in programma di trattare il tema.
Ma Trump non aveva già lasciato gli accordi del clima?
No. L’anno scorso aveva annunciato il ritiro dall’Accordo di Parigi (con efficacia dal 20 gennaio prossimo), che sotto l’ombrello dell’Unfccc sta.
Gli Usa, insomma, potevano ancora partecipare come osservatori alle conferenze del clima, le Cop. E possono accora, volendo.
Lasciando la Unfccc, se mai avvenisse, uscirebbero completamente di scena.
Tutti gli altri Stati del mondo aderiscono alla Convenzione Onu: si tratta di oltre 190 paesi che si trovano più volte all’anno a negoziare.
Ma perché sarebbe importante questa decisione?
Perché il presidente porterebbe fuori Washington dal processo per la cosiddetta governance globale del clima. Il processo, intrapreso 34 anni fa con la Conferenza di Rio, che cercava di trovare un coordinamento tra le politiche internazionali in materia.
Ed è proprio quello che l’amministrazione guidata dal commander in chief newyorchese non vuole.
Peraltro, Trump non si è limitato al clima: con lo stesso atto ha chiesto di ritirare gli Usa da altre 65 organizzazioni internazionali.
“Come questa lista inizia a dimostrare, quello che è cominciato come un quadro pragmatico di organizzazioni internazionali per la pace e la cooperazione ha preso le sembianze di una estesa architettura di governance globale, spesso dominata dall’ideologia progressista e staccata dagli interessi nazionali”, ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.
Il rapimento di Maduro in Venezuela, il sequestro di una petroliera russa, le minacce alla Groenlandia, i dazi e il ritiro dalla cooperazione internazionale dei mesi scorsi, quello paventato dalle organizzazioni di governance globale ieri: la politica dell’inquilino della Casa Bianca comincia ad apparire sempre più disordinata e figlia di un delirio di onnipotenza.
La strategia di sicurezza nazionale pubblicata a dicembre offre una chiave interpretativa, che peraltro fa riferimento a presunti diritti divini allo stile di vita americano. Ma non basta.
In realtà non ci troviamo solo di fronte a un declino di una grande potenza, e dell’Occidente in generale. Potrebbe trattarsi di un declino cognitivo del presidente, che, nel secondo mandato, forte dell’esperienza del primo, si è circondato di yes men e ha piazzato una pletora di fiduciari in tutti i gangli della macchina amministrativa.
Le istituzioni statunitensi, che nel 2016 avevano retto, oggi traballano.
Non è chiaro il limite, ammesso che ci sia. Non è chiaro nemmeno quando la corda si spezzerà. Ma in tutti i discorsi che vengono fatti manca un elemento: la politica interna. Vuol dire che Trump non può essere fermato dall’esterno: una potenza nucleare, ed è vero in particolare per la più grande del mondo, non può essere controllata con la forza. La speranza va riposta negli americani stessi. Sono loro gli unici a poter fermare l’uomo che, per due volte, hanno messo al comando. Una reazione della società civile è necessaria. Una reazione che, fino a oggi, non c’è stata.
Per completezza di analisi va detto che Trump ha sicuramente, prima di altri, evidenziato il declino dell’Occidente nel corso del primo mandato, sottolineando che il nuovo avversario stava a Pechino, non a Mosca. Ha anche più di qualche ragione nel sostenere che il paese asiatico ha avviluppato il mondo in una rete economica da cui è difficile, molto difficile uscire quando vi si entra. E che non lo abbia fatto per filantropia, ma per interesse – si vede bene in Africa, e pure in Sudamerica -. Tra le condizioni per essere aiutati dal Dragone economicamente (ma parlianmo in buona parte di prestiti, non di grant), in particolare, ve n’è una che serve a comprendere: riconoscere l’esistenza di “una sola Cina”, cioè la non indipendenza di Taiwan.
Comprensibile che, vistasi sfidata sul proprio continente (la dottrina Monroe ha due secoli, ma è sempre attuale), la superpotenza sia in allerta e cerchi contromisure. Ma le relazioni commerciali sono state il modo che l’umanità ha trovato per non farsi la guerra: la stessa Unione europea, tentativo fatto dopo due devastanti guerre mondiali, si basa su questo concetto. Non si può pretendere di cambiare il corso della Storia con le minacce o, peggio, con le armi. Anche il tentativo della globalizzazione (per molti versi fallimentare, ma non sotto ogni punto di vista) è stato questo: usare il commercio come leva per evitare di far ricorso ai cannoni.
E Pechino? La Cina, mentre il mondo cambia alla velocità della luce, ragiona sul lungo periodo, e sta alla finestra. Trump passerà, pensa probabilmente Xi Jinping. Bisogna vedere cosa resterà di lui.