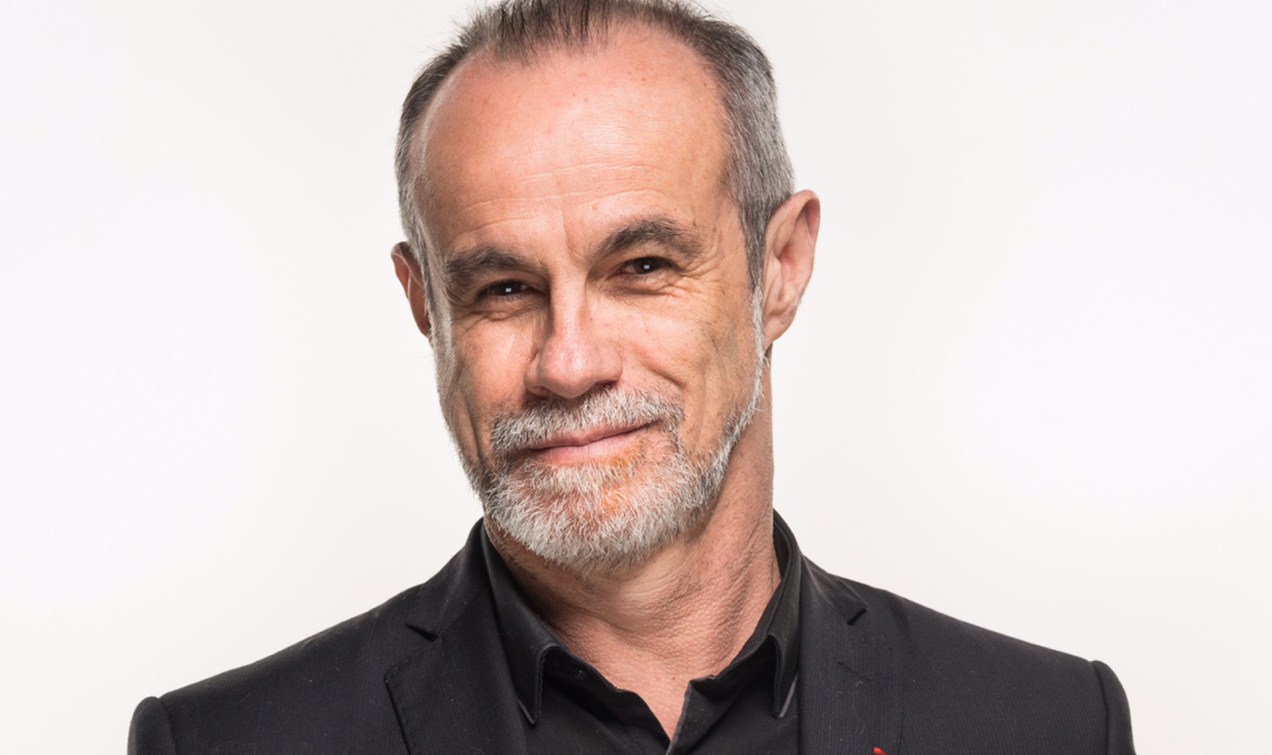Può capitare che si organizzi un’intervista, e che per qualche motivo non esca. Può capitare anche che ce la si dimentichi in una cartella del pc. Mi è accaduto – mea culpa – con Carlos Moreno, il teorico della città dei quindici minuti, di gran moda a livello globale e con cui avevo parlato un annetto fa durante la presentazione del progetto del nuovo piazzale Loreto, di cui è sponsor. La riporto qui. Cerniera tra centro e periferia, piazzale Loreto, uno dei luoghi più transitati del capoluogo lombardo, sarà completamente ridisegnato. Spariranno o quasi le auto; appariranno pedoni, alberi e negozi.
Tutto bene? Non proprio. In una città dai valori immobiliari impazziti come la Milano di oggi, un progetto del genere allarga la portata della bolla, espellendo residenti e storici negozianti per far posto a chi può permettersi di reggere il passo. E’ già accaduto nella vicina NoLo (nuovo nome con cui si è chiamata una delle strade più scalcagnate di Milano e la si è resa appetibile); sta avvenendo a Porta Romana e in molti altri quartieri. Il fatto è che una città è un organismo per propria natura imperfetto; cercare la perfezione genera mostri. Vendibili, forse, ma inabitabili. E non sempre i cittadini sono d’accordo. Ecco il pezzo.
Lei è il teorico della città dei quindici minuti, modello applicato in diverse metropoli mondiali. Per esempio, la Parigi di Anna Hidalgo. Come sintetizza il suo pensiero?
Se dovessimo riassumerlo, potremmo dire che l’obiettivo è definire una città policentrica, decentralizzata, dotata di molti servizi differenti, con una forte riduzione delle distanze. Una città che sviluppi infrastrutture dalla destinazione d’uso plurima. E ultimo, ma non per importanza, una città in grado di sviluppare nuovi modelli economici, per dar luogo a un’economia locale più vibrante, occupazione locale, minore uso delle materie prime.
Da dove, da cosa ha tratto ispirazione?
Da molti pensatori, ma la mia maggior fonte di ispirazione è stata Jane Jacobs, attivista e scrittrice nordamericana, che ha sviluppato il concept della “living city” . Ma non solo: ci sono il new urbanism, il new pedestrianism. In Italia avete la grande scuola di Aldo Rossi. Ho proposto un nuovo paradigma nel punto di convergenza tra le idee di molti pensatori e doers, per attualizzarle al ventunesimo secolo. Un tempo di grandissima urbanizzazione, segnato dalla crisi climatica e da altre come il covid e la guerra.
La pandemia ha fermato il mondo per mesi, costringendoci a ripensare le nostre abitudini. Quanto ha cambiato il covid la prospettiva dei sindaci?
Si è trattato di un crisi molto profonda, ma anche di una grande opportunità per trasformare il modo in cui lavoriamo. Innanzitutto, invece di continuare con lunghe ore di pendolarismo molte persone hanno imparato a lavorare in maniera diversa con la ibridazione tra presenza fisica e attività in remoto. Il secondo punto è che le persone, specialmente tra i venti e i quarant’anni, hanno scoperto il “tempo utile”, cioè la possibilità di avere tempo a disposizione per attività personali, familiari, sociali. E’ una conseguenza del nuovo modo di lavorare: se la gente ha la possibilità di ridurre i lunghi tragitti da pendolare, questo tempo in più offre finestre per sviluppare nuove attività sociali e amicali. Terzo, con il covid molti hanno scoperto nuove risorse di prossimità: aree verdi , negozi locali, attività culturali e sportive: risorse che si trovano già nello spazio urbano e sono vicine a noi.
Ci sono già molte città in cui le sue teorie sono state applicate: quali sono?
Ne abbiamo tante, in effetti, sparse per il mondo. La novità è l’impegno del C40, di cui fanno parte Roma e Milano. A Milano, il sindaco Sala è totalmente coinvolto. La campagna elettorale per la sua rielezione è stata basata sulla città dei 15 minuti; Roma è nella stessa situazione. Anche in Europa gli esempi non mancano: Lisbona, Barcellona, la nazione scozzese – non solo una città, ma tutta una regione – . Recentemente non solo Parigi, ma tutta la regione dell’Ile de France ha abbracciato questo concept. E poi Buenos Aires, Bogotà, Portland, Cleveland, Seattle, Seul, Susa (tra le più grandi città della Tunisia). In Senegal, la capitale Dakar e in Polonia persino molte zone rurali.
Con la pandemia è cambiato il modo di percepire le città,. Ma gli effetti non hanno solo segno positivo. A volte, migliorando la città l’effetto è espellere certe fasce della popolazione. Milano probabilmente sta commettendo questo errore. Che ne pensa?
Dobbiamo sviluppare il concept della città dei 15 minuti con l’idea di ribilanciare le città. Alcune dinamiche si ripropongono simili in tutti i continenti: una gentrification forte e importante, una frammentazione, una zonizzazione. Con la città dei 15 minuti vogliamo proporre una nuova politica urbana, per arrivare a un nuovo processo decisionale e a un ribilanciamento verso una città policentrica. Ognuno di questi nuovi poli deve offrire servizi culturali, negozi, sport e rigenerare l’occupazione locale. Per quanto riguarda l’housing, dobbiamo promuovere policy per avere social housing e limitare i prezzi di affitti e appartamenti.
Insomma, questo concept deve essere accompagnato da policy sociali.
Con l’esperienza che abbiamo oggi, è molto chiaro che dobbiamo mixare l’housing per la classe media con quello di alto livello. La chiave di volta per implementare con successo la città dei 15 minuti è il mix massivo di categorie sociali e funzionalità. E’ possibile se ci diamo l’obiettivo di creare un percorso che conduca a un ecosistema pubblico-privato. Dobbiamo creare queste alleanze per generare nuovi modelli di business, e sviluppare questa coesistenza.
Il processo di ridefinizione di una città nell’ottica dei quindici minuti può essere vissuto dalla popolazione come top-down: il sindaco decide, la popolazione esegue. Ci sono altri approcci più partecipativi che sostengono, invece, che sia necessario ascoltare di più la voce dei residenti. Per esempio, ci sono esperimenti in Svezia al riguardo. Che ne pensa?
Dopo anni di lavoro con tanti sindaci e associazioni civiche posso dire che non c’è una ricetta valida per tutti: [ridisegnare una città] è un processo di lungo termine il cui punto cruciale è combinare tutti gli elementi in maniera ottimale. Per seguire questa traiettoria, abbiamo senz’altro bisogno di un forte impegno dei sindaci a sviluppare nuove policy urbane, ma allo stesso tempo è necessario sviluppare un impegno rilevante da parte dei cittadini. Un grande esempio è proprio qui a Milano con la community Loreto 2026. Oggi c’è una rotonda completamente dedicata alle macchine, che potremo definire un attrattore di ingorghi. Molti passano un sacco di tempo in auto, eppure si rifiutano di abbandonarla. Per cambiare, dobbiamo creare accettabilità sociale: questa è la grande domanda per me, perché questa trasformazione coinvolge un sacco di persone differenti. Dobbiamo combinare le decisioni strategiche degli amministratore con la partecipazione. Col mio gruppo di lavoro all’università abbiamo sviluppato un nuovo tool che si chiama Proximity Fresk, un gioco materiale per sviluppare la partecipazione dei cittadini: prendono una mappa del territorio, cominciano a ragionarci, e si chiedono quali sono gli ostacoli che impediscono la trasformazione. Dobbiamo combinare visione strategica e partecipazione, e per questo occorre creare nuovi strumenti.
Come può aiutare la tecnologia?
Può aiutare a visualizzare i differenti stadi del progetto, per esempio a far vedere come diventerà l’area su cui oggi sorge la rotonda di piazzale Loreto dopo la trasformazione. Ci saranno fasi molto dure per gli abitanti durante i lavori: i trasporti saranno disturbati per più di un anno, per esempio. Le tecnologie potranno servire per spiegare quello che accade e monitorare, e avere in questo modo un ruolo pedagogico.