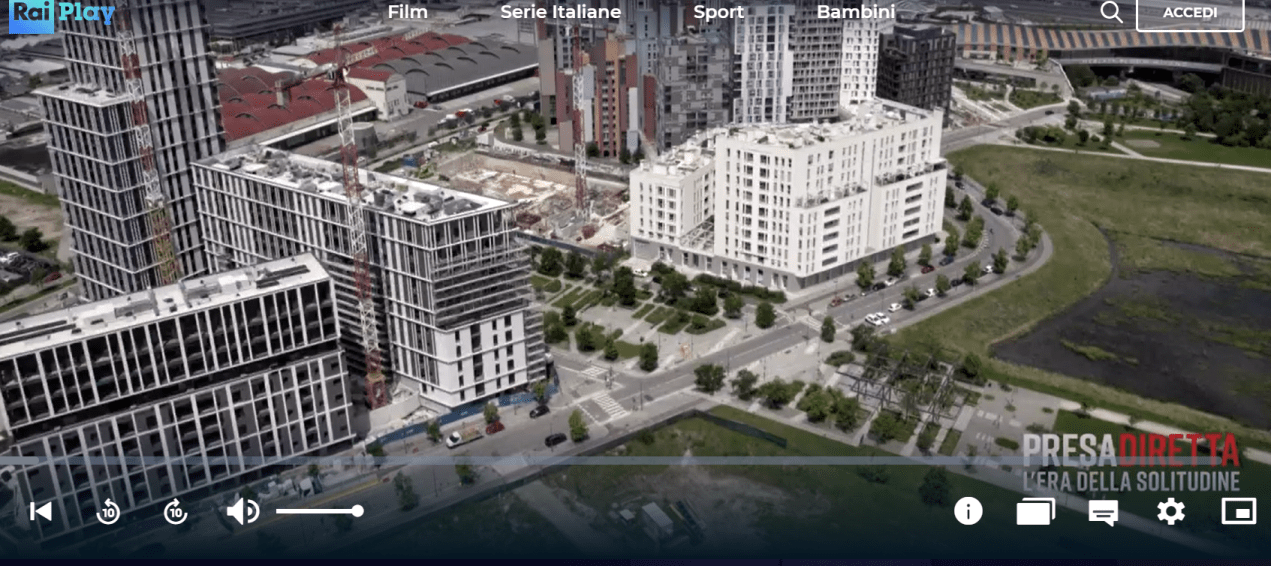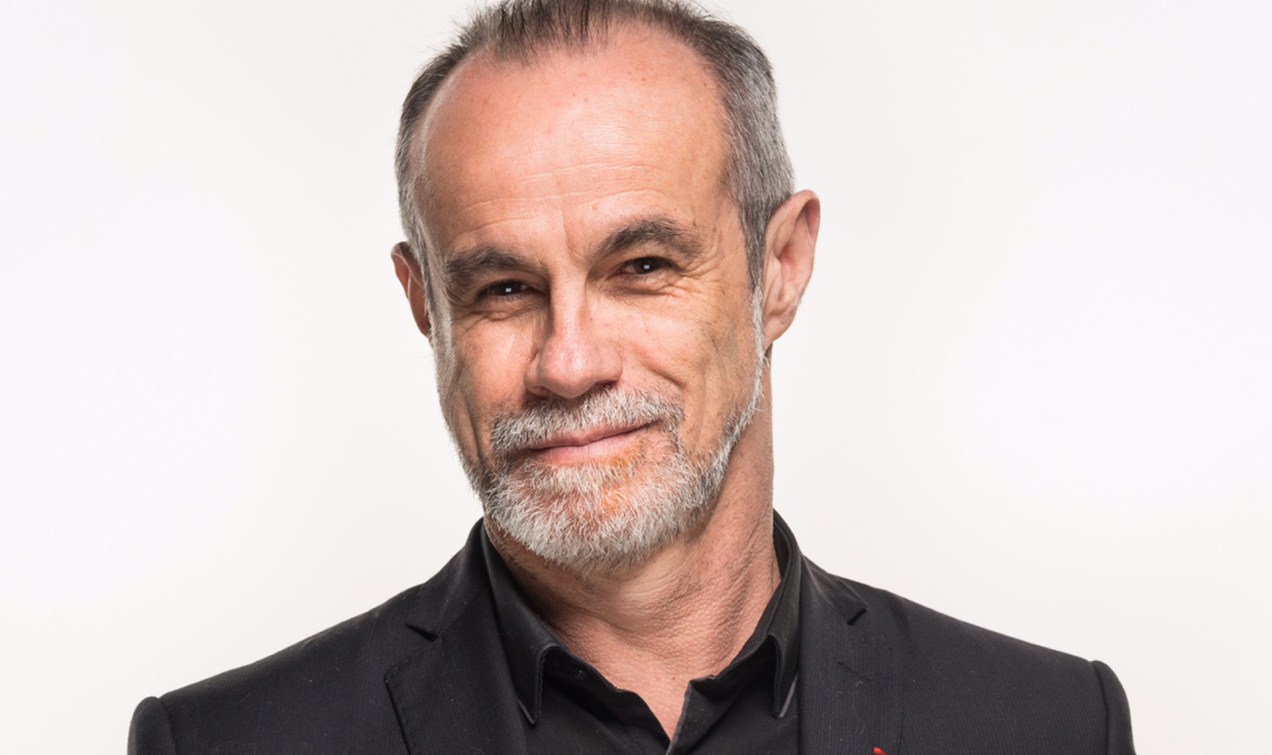Belém (Brasile) – Niente riferimento alla tabella di marcia per la transizione dalle fonti fossili, ma un impegno a triplicare i fondi per l’adattamento. E la dimostrazione che, nonostante tutto, la diplomazia climatica può fare a meno degli Stati Uniti. E’ una conclusione agrodolce quella della Cop30. Belém poteva essere storica, e non lo è stata. Ma almeno non ha rappresentato un tracolllo rispetto alle scorse edizioni di Baku e Dubai. Raccolgo qui qualche considerazione.
- Che cosa vogliono i paesi che bloccano il negoziato? Il mondo va verso la transizione energetica, innegabilmente. Nessuno, neanche gli Stati che si basano sul petrolio o sul gas (petromonarchie del Golfo, Russia) può illudersi di fermare o invertire il processo. E allora cosa vogliono? Influenza. Al potere ci si abitua: e il petrolio ha dato ampi margini a territori desertici che altrimenti sarebbero stati ignorati. In Medio Oriente stanno investendo per garantirsi rendite post petrolio, e il tempo in finanza è un fattore chiave: quindi rallentare ha senso per incamerare più risorse. Ma agire da veto-player, piccoli attori che sfruttano le falle dei meccanismi negoziali per bloccare tutto e avere visibilità (pensate ai partitini decisivi per costituire le maggioranze) è anche un modo per affermare la propria diplomazia e il proprio ruolo, anche di ponte culturale, senza tornare piccoli e insignificanti.
- Tutto è legato nel mondo di oggi. L’ambiente è il tema principale per noi che frequentiamo le conferenze del clima. Ma la realtà è che è usato come merce di scambio su altri tavoli. Per ottenere concessioni tariffarie, per esempio – non a caso si è parlato tanto di commercio in questa Cop. Non è solo clima, dunque: quando una delegazione riceve ordini per negoziare su una certa posizione, bisogna sempre guardare al contesto geopolitico. Esempio: l’Ucraina non può essere a favore delle fonti fossili (gradite alla Russia, che le esporta). Ma non può dirlo, perché il principale alleato è l’America di Trump. Queste situazioni sono la regola, non l’eccezione. L’India ha un problema demografico e di povertà: negozia sull’ambiente per ottenere altro. Lo stesso Brasile scambia l’Amazzonia con altro. Vicende come quella dei marò insegnano che per avere visibilità ci si attacca a questioni-simbolo. Vale anche per il clima.
- Esistono questioni globali, come l’Amazzonia, polmone verde del mondo, che appaiono molto diverse a livello locale. Se per il mondo salvare la foresta tropicale è una priorità, per paesi che hanno bisogno di crescere – e il Brasile sta cercando di diventare una media potenza – , tutto fa brodo: è l’economia dello sviluppo che chiede di chiudere un occhio, forse anche due, per superare la fase di decollo e raggiungere la massa critica. Lo abbiamo fatto anche noi in Italia, lo sta facendo la Polonia, lo ha fatto la Cina – ricordiamoci le Olimpiadi di Pechino con l’aria nera per lo smog, ed era solo il 2008. Funziona così. Fare finta di scordarselo è ipocrita; non saperlo è ignoranza.
- Passare all’elettrico è necessario. Ma ha i suoi costi. Alti. Anche qui, la differenza tra questione globale e impatto locale. L’estrazione del litio e delle terre rare, necessarie per la transizione, sta devastando interi territori. Se ne parla poco, pochissimo. Ma dall’Amazzonia si vede. Qui vicino, in Cile, Argentina, e poi in Africa e nella stessa Cina, questi materiali sono il nuovo petrolio, inteso anche come potere di distruzione. Quanto si può scaricare su paesi e persone il costo di un modello di sviluppo globale basato sullo spreco? Nei prossimi anni, risolto il tema del clima, il problema sarà questo.
- La Cina non vuole essere leader di nulla. Essere avaguardia comporta responsabilità, quantomeno morali. Che Pechino non vuole. Se fa la transizione, la fa per interesse. Nessuno , in politica, agisce per idealismo: ma la saggezza millenaria insegna ai governanti cinesi che è meglio pensare ai fatti propri. Anche perché, nelle conferenze del clima, la Cina è ancora considerata un paese in via di sviluppo, come era quando le regole furono scritte, nel 1992. Diventare leader significa uscire da quelle tabelle, e quindi pagare di più.
- Il processo negoziale ha funzionato per trent’anni, ma va riformato. Il problema è come. Non siamo più nel mondo della globalizzazione, dove si rincorreva l’illusione di un governo mondiale. Molte delle cose positive di questa cop30 sono avvenute nei tavoli laterali. L’aveva previsto l’amico Jacopo Bencini. Il fondo per le foreste tropicali dei primi giorni, il consenso per una conferenza sulle fonti fossili (aprile 2026, Santa Marta, Colombia, paese che l’ha lanciata con la pasionaria Irene Velez Torres). La roadmap per la transizione, che ha aggregato consenso da parte di 84 paesi, lanciata dal Brasile, che porterà avanti l’idea nei prossimi mesi. Tutto bello. Ma il vantaggio dell’Onu è che offre una cornice strutturata. Le procedure sono noiose, ma salvano. E’ la differenza tra un’azienda e una startup: di queste ultime, dopo un anno sopravvive una su dieci. Dopo cinque? Ancora una su dieci. Di quelle che rimangono. E quelle che resistono, se crescono di scala, si danno delle regole. Una conferenza organizzata così può avere un paio di edizioni: ma come deciderà? Cosa succederà in caso di impasse? Chi darà le carte? L’Onu ha risposte per tutte queste domande, risposte condivise e frutto di un processo di creazione di conoscenza e cultura negoziale quasi secolare, e sicuramente secolare se guardiamo anche all’esperienza della Società delle Nazioni. Il tentativo è apprezzabile, ma non si può abbandonare le Nazioni Unite pensando di farne a meno: ben vengano le iniziative collaterali, anche come stimono a un processo di riforma. Ma non illudiamoci.
- Le piccole isole, che l’anno scorso avevano inscenato un drammatico walk out, quest’anno si sono sentite poco. Era la cop della foresta. Ma loro rischiano di finire sott’acqua. Peccato.
- La sospensione della plenaria (richiesta da Panama) non deve diventare una norma. Colpi di mano della presidenza devono essere evitati il più possibile, perché ormai ci sono paesi che, anche grazie ai nuovi media, anche se piccoli godono di visibilià e influenza, al punto da prendere la parola e bloccare tutto. Soluzione: niente forzature alla Al Jaber. Si ascoltano tutti. Sarà più lunga, ma per decenni ai piccoli è stata data solo l’illusione di contare. Oggi non è più così: stanno nascendo nuove alleanze, e si sentono spalleggiati. Vanno inclusi.
- Si può fare a meno degli Stati Uniti, nella diplomazia climatica. Certamente, se Washington avesse appoggiato la roadmap, la si sarebbe fatta – questo per dire il peso specifico. Non è solo questione di Trump: un passo del genere non lo avrebbe supportato neanche Biden. Però il multilateralismo ha retto. Mi è piaciuto anche il ruolo delle città in questa conferenza, più visibili: è un aspetto su cui lavorare.
- Una relazionalità esasperata alle conferenze del clima. Biglietti da visita, strette di mano, salamelecchi. Nessuno si salva, neanche chi scrive. Ma forse è il momento di tornare a pensare un po’ più al nostro lavoro, e un po’ meno a noi stessi. Da Belèm è tutto, appuntamento in Turchia.