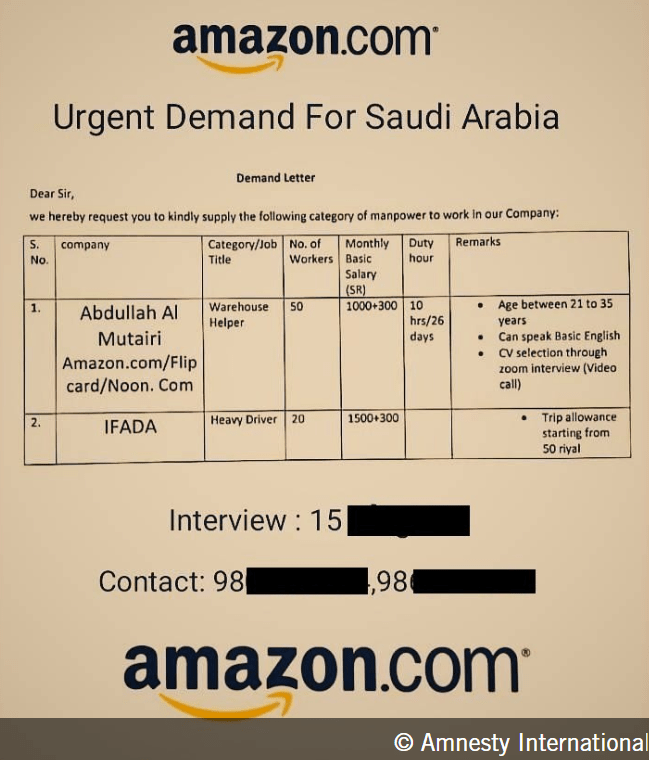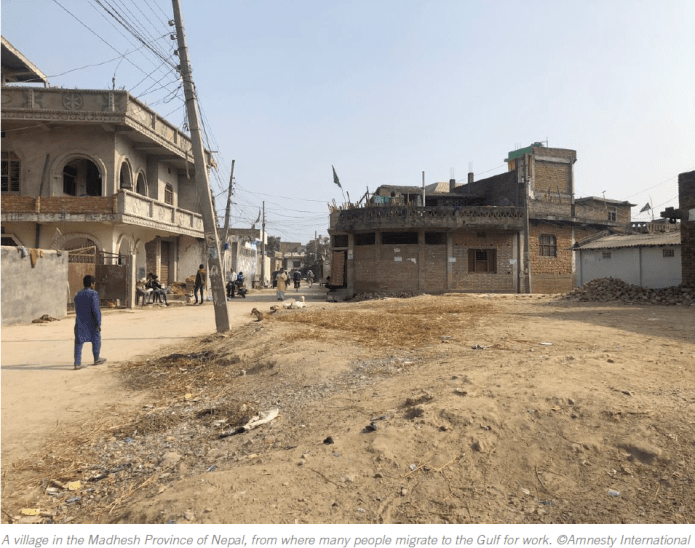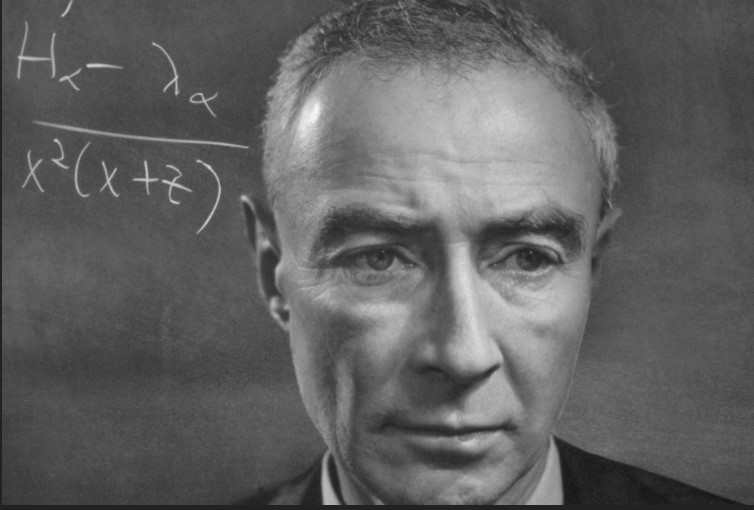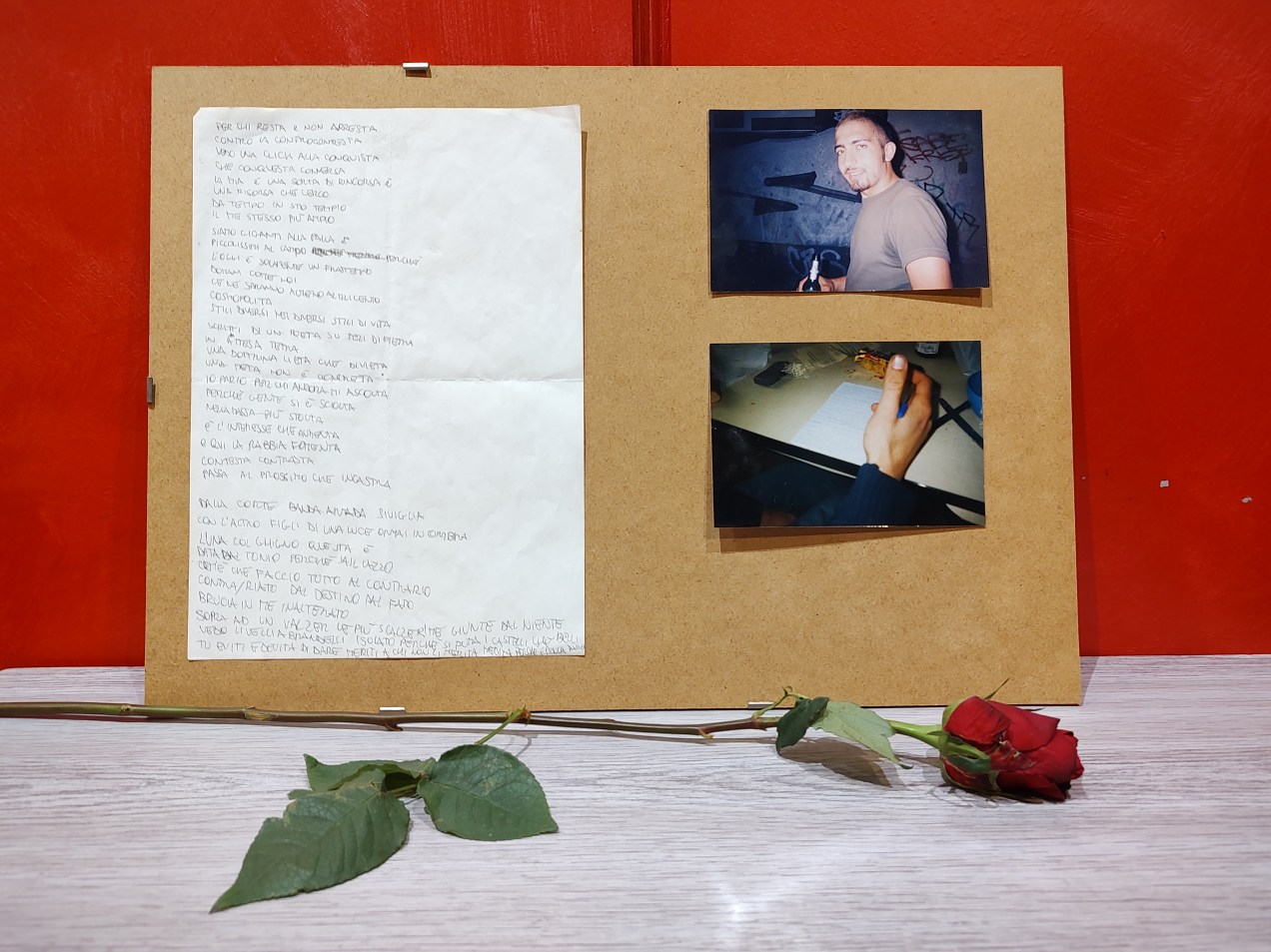Ottocentocinquanta dipendenti delle istituzioni europee (su circa trentaduemila) hanno firmato una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen che ne critica il “sostegno incondizionato” a Israele. La notizia è stata riportata da Euractiv. Si tratta di un atto insolito, perché a Bruxelles il personale è abituato a girare tra dipartimenti e uffici nel corso di una carriera che resta ambita, ed è, pertanti, attento a costruirsi un percorso in grado di adattarsi agli inevitabili cambi di vento. Non questa volta.
“In particolare, siamo preoccupati dal supporto incoindizionato della Commissione europea che lei rappresenta per una delle due parti” si legge. “Noi, un gruppo di dipendenti della Commissione e altre istituzioni Ue, condanniamo solennemente su base personale l’attacco terroristico perpetrato da Hamas contro civili inermi […] Ma condanniamo ugualmente e con forza la reazione sproporzionata del governo israeliano contro i 2,3 milioni di civili palestinesi intrappolati nella striscia di Gaza”. “Proprio per via di queste atrocità, siamo sorpresi dalla posizione presa dalla Commissione europea – e anche da altre istituzioni – che hanno promosso quella che sulla stampa è stata descritta come ‘cacofonia europea’ “. I firmatari si dichiarano preoccupati per “l’apparente indifferenza dimostrata nei giorni scorsi dall’istituzione nei confronti del massacro di civili a Gaza, in violazione dei diritti umani e delle leggi umanitarie internazionali”.
Nei giorni scorsi era arrivato il dietrofront della Commissione dopo che il commissario ungherese all’allargamento Oliver Varhely aveva annunciato che l’esecutivo di Bruxelles avrebbe tagliato “tutti gli aiuti” ai Palestinesi, generando la reazione delle altre entità politiche comuni – la posizione dell’Unione viene espressa dal Consiglio, cioè dagli Stati membri, e le sfumature sono parecchie. “Vi invitiamo con urgenza a invocare, assieme coi leader di tutti gli Stati [membri], un cessate il fuoco e la protezione della vita dei civili. Questo è il cuore dell’esistenza europea” hanno aggiunto i firmatari. “L’Europa rischia di perdere ogni credibilità”.
Sabato 22 ottobre un summit per la pace organizzato al Cairo si è concluso senza una dichiarazione finale: il blocco occidentale chiedeva di inserire nel testo solo un riferimento all’attacco di Hamas, senza menzionare i raid israeliani su Gaza. L’opposizione degli altri partecipanti ha portato il vertice a chiudersi con un nulla di fatto.