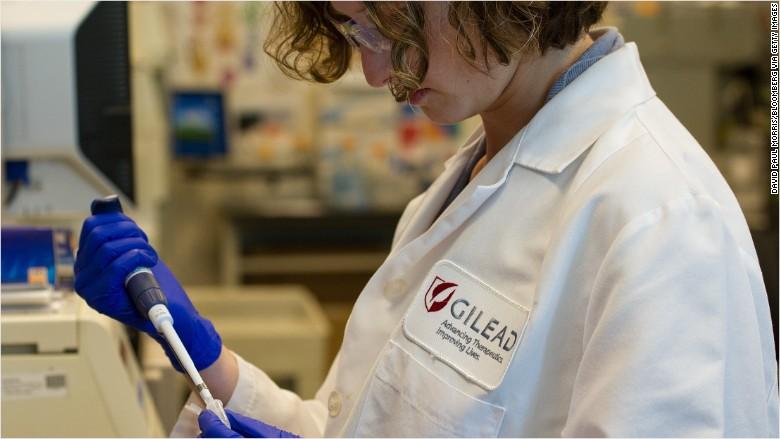Non c’è certo bisogno di un’altra voce nel frastuono di opinioni sul referendum costituzionale del 4 dicembre. E poi, prendere posizione su una questione del genere espone a un rischio: quello di trovarsi, fra qualche anno, a dover difendere le conseguenze della propria scelta.
Ciò premesso, nascondersi è, probabilmente, peggio. Tanto più che il dibattito ha assunto toni da stadio e sono in pochi ad aver letto la riforma. Per la cronaca, bastano un paio d’ore.
Un documento molto utile si può trovare a questo link. L’autore ha messo a confronto il (vecchio?) testo della Costituzione con il nuovo. Preciso che non conosco la fonte, ma mi sembra un lavoro scarno e ben fatto. L’essenziale per farsi un’idea. Se non altro, serve a mettersi la coscienza a posto.
I PUNTI CRITICI – Le questioni poste dal fronte del NO mi sembrano essenzialmente tre: l’accoppiata riforma costituzionale – Italicum, che determinerebbe uno scadimento della democrazia; la maniera in cui il Senato verrebbe riformato; i rapporti Stato-Regioni.
Tralascerei il primo argomento: Renzi si è detto disposto a modificare l’Italicum, procedura per cui basta la legge ordinaria. Ovviamente la legge elettorale è importante per un paese sano: la scelta fra maggioritario e proporzionale è quella tra un sistema volto a garantire la governabilità e uno che predilige la rappresentatività. Una questione complessa, che merita ben più ampia trattazione. Ponendoci nella condizione che lo faccia, facciamo un passo avanti e spostiamoci al resto.
Dopo la riforma, il Senato passerà a 100 membri. Si poteva abolirlo, si è scelto di mantenerlo. Non mi dispiace, a dire il vero. Rappresenterà le Regioni (ma era già eletto su base regionale, e l’intento dei costituenti era proprio quello di garantire rappresentanza ai territori). Sicuramente il fatto di mandare a Roma sindaci e consiglieri regionali poteva essere evitato perché attendere bene a un compito solo è già molto, soprattutto a certe, mediterranee, latitudini. Ma tant’è.
Si fornisce sicuramente potere ai partiti, nell’ottica di una democrazia rappresentativa che medi le istanze del corpo elettorale. Ma con una legge elettorale valida a livello locale – e quella che elegge i sindaci lo è – si potrebbe, in via teorica, selezionare una classe di politici competenti a portare nella Capitale i bisogni dei territori.
Preciso, per dovere di cronaca, che preferirei l’elezione diretta dei senatori, sul modello americano. Ma si tratta di un dettaglio che potrebbe essere oggetto di ulteriore riforma fra una decina d’anni, il tempo di verificare la validità della proposta attualmente in discussione: queste valutazioni, l’esperienza insegna, si possono fare solo “sul campo”.
A garantire una base di democraticità, il fatto che, in fondo, i nuovi senatori saranno uomini e donne già eletti una volta; toccherà, poi, alle segreterie scegliere che spedire a Roma facendo convergere i voti su questo o quel candidato.
Il nuovo Senato non avrà il potere di votare la fiducia al Governo, né di approvare leggi ordinarie. Queste prerogative spetteranno solo alla Camera dei Deputati (che resterà eletta dai cittadini), tranne alcune eccezioni (ad esempio le leggi costituzionali). I senatori potranno, dal canto loro, proporre a Montecitorio disegni di legge, gravati dall’obbligo di esaminarli nel giro di qualche settimana.
Sulle leggi votate alla Camera, invece, il nuovo Senato potrà esprimere un parere non vincolante, senza però bloccarle.
Nel complesso, mi sembra che questa riforma raggiunga l’obiettivo di delineare un processo decisionale più snello: la “navetta” parlamentare, per cui ogni modifica da parte di una delle Camere provocava con effetto immediato la ripartenza dell’iter, è evitata.
Camera e Senato hanno spesso visto maggioranze differenti, e con il “vecchio testo”, i compromessi non potevano che essere al ribasso, producendo leggicchie spesso inutili e difficili da superare, anche perché, nel loro cerchiobottismo, non scontentavano mai completamente nessuno.
Il tema della accountability (la responsabilità) è affrontato: si sa di “chi è la colpa” di questa o quella politica, e dopo cinque anni si può decidere di votare diversamente. Che poi questo accada davvero, in un paese legato alle appartenenze ideologiche più che ai programmi, è un altro discorso. Ma è giunta l’ora, anche per gli elettori, di farsi un esame di coscienza: Berlusconi non si è eletto da solo, i corrotti della Prima e Seconda Repubblica tantomeno.
Nel nuovo testo, è tutelato il ruolo del presidente della Repubblica, e anche la figura del presidente del Consiglio risulta invariata, a differenza di quanto accadeva nella riforma del 2006 (centrodestra), poi bocciata alle urne.
IMMUNITA’ – Altro tema, sollevato da Marco Travaglio e dal suo Fatto Quotidiano: i senatori continueranno a godere dell’immunità parlamentare, esattamente come accade ora. Il timore del giornalista è che un Palazzo Madama svuotato di competenze si riduca ad ad essere, semplicemente, ricettacolo di figure impresentabili da proteggere dalla giustizia. Gli anni del Porcellum hanno mostrato come si possa sfruttare il Parlamento per far eleggere, tramite liste bloccate, ogni sorta di impresentabile alle prese con i tribunali. L’Italicum, che quelle liste ripropone, non aiuta; ma è un fatto che anche le preferenze abbiano prodotto clientelismo e corruzione. Ripeto, si tratta di un tema diverso, che va affrontato separatamente tramite legge ordinaria, e non pregiudica la validità della riforma nel suo complesso. Il dibattito dovrà essere ampio, questo è certo.
Renzi osserverà che l’immunità era stata prevista già dai padri costituenti: ma allora si voleva garantire che i membri del Parlamento esercitassero liberamente le proprie funzioni. Mancando queste, ne decadono i presupposti. Più probabilmente, si è trattato di una concessione alla vecchia politica, sempre ansiosa di salvacondotti da usare alla bisogna. Si perde, certo, un’occasione, ma si tratta di una questione secondaria che potrà essere risolta in seguito.
COMPETENZE – Quelle del nuovo Senato, come già detto, saranno ridotte all’osso: in parole povere, rappresentare le istanze locali davanti alla Camera e al Governo e poco altro, ai fini pratici. E allora perché non privarsene del tutto? La prima ragione è squisitamente politica: un organo di raccordo serve, ed è previsto in quasi tutti gli ordinamenti parlamentari. La seconda è umana: credere che i parlamentari avrebbero votato facilmente un’auto-distruzione di Palazzo Madama suona molto ingenuo.
Sintetizzando: la riforma del Senato ci può stare, posto che si avverta la necessità di semplificare il processo decisionale.
Se invece, per qualsivoglia motivo, si preferisce mantenere in piedi un’architettura costituzionale ridondante creata dopo il ventennio fascista e con il pericolo comunista alle porte, un bicameralismo ipergarantista e pachidermico, il problema è questo, non come la riforma è stata fatta. Ricordiamo che molti parlamentari hanno cambiato idea dal 2014, quando il testo fu licenziato. Mi sembra che il referendum sia diventato terreno di scontro politico, una sorta di regolamento dei conti (anche interni al PD) che esula dal merito.
RAPPORTI STATO – REGIONI – Il testo di Renzi sembra fornire una chiarificazione nei rapporti Stato – Regioni, riscrivendo l’elenco delle competenze. Il baricentro, che nel 2001 era stato spostato a livello locale, tornerà a Roma.
La riforma di allora, voluta dal governo Amato, era figlia della rincorsa alla Lega. Si riteneva che il problema dell’Italia risiedesse nella eccessiva centralizzazione di certe decisioni, che meglio sarebbero state assunte a livello locale.
Gli effetti non sono stati quelli sperati. A fronte di una gestione migliore delle risorse in certi contesti, sono aumentati gli sprechi: la sanità, che nel 2001 costava 75 miliardi, oggi ne costa 110, come riporta Linkiesta.
Non solo. Le normative regionali sono spesso ampiamente discordanti, e non di rado si verificano conflitti di competenza con lo Stato, che devono essere risolti in sede amministrativa.
Il punto più importante, però, è un altro. Le decisioni strategiche per l’interesse nazionale vanno prese nell’interesse di tutti, non solo dei governi locali. Questo accade oggi? Non sempre.
L’Italia ha un deficit di senso della comunità; è stata unificata relativamente di recente; la celebre frase di Massimo D’Azeglio (“L’Italia è fatta, adesso bisogna fare gli italiani”, che potrebbe applicarsi bene anche all’Europa) rende perfettamente la situazione. Anche 150 anni dopo.
Esigenze diverse, storie diverse, un solo governo. A inizio secolo, la Lega sembrava fornire le risposte a chi chiedeva a gran voce autonomia. Soprattutto, la chiedeva il Nord, che viaggiava e viaggia a un altro passo rispetto al Meridione e al Centro. Ma mani libere potevano fare comodo agli intrallazzi di molti anche nelle regioni del Sud. Gli allora DS si assunsero l’onere di provvedere, anche in vista delle elezioni.
Com’è andata lo sappiamo: vinse ugualmente Berlusconi, assieme a Bossi. I due cercarono di portare a casa una riforma costituzionale di taglio marcatamente federalista, con un premierato forte. Fu percepita – a mio parere giustamente – come una rivoluzione copernicana che snaturava la Repubblica, e venne bocciata alle urne nel referendum del 2006.
SUPERARE IL 2001 – La riforma del 2001 è superata. Non c’è più spazio per gli eccessi di particolarismo nel mondo contemporaneo. La Lega ha mostrato i propri limiti una volta passata da partito antisistema a forza di governo, ed è finita al centro di inchieste dal sapore più romano che lumbard, perdendo la credibilità che aveva garantito sulla bontà delle proprie istanze. Ma non solo.
Il fatto è che quello di allora era davvero un altro mondo, con certezze che oggi appaiono lontane. Non c’erano ancora stati l’11 settembre, le guerre in Iraq e Afghanistan. Dell’esistenza di Al Qaida sapevano in pochi, molti soldati dell’ISIS facevano le elementari – alcuni frequentavano l’asilo -; la pax americana garantiva una certa serenità a un mondo che nel ‘91 si era scoperto unipolare. Noi eravamo nella parte giusta del mondo, quella ricca, senza concorrenti. La Cina cresceva a tassi record ma era lontana, l’India molto più indietro, la Russia rimasta orfana di Eltsin e in mano agli oligarchi sembrava incapace di trovare una stabilità. Di Brexit non si parlava, si era anzi nel pieno della Cool Britannia di Tony Blair e della Terza via. In usa presidente era Clinton, quello vero.
La globalizzazione era agli albori, e se qualcuno avvertiva che gli effetti potevano essere devastanti – il G8 di Genova risale proprio al 2001 – erano in molti a credere che avrebbe portato benessere, facilitando gli spostamenti di capitali, la delocalizzazione, gli investimenti slegati dal territorio. Non c’era ancora stata la crisi.
Oggi, la Cina è alle porte, e assieme all’India assomma 3 miliardi di persone; la Russia ha trovato in Putin l’uomo forte in grado di rinnovarne la politica di potenza; ci sono l’ISIS, il terrorismo e le polveriere africana e mediorientale: tutti schierati “contro” l’Occidente. Impensabile restare da soli, impensabile ragionare in senso locale.
C’è, invece, bisogno di prendere decisioni strategiche che ci inseriscano in un ecosistema più ampio, e questo può essere fatto solo da un governo forte, in grado di dirigere il paese. Servono risposte rapide, adeguate alla rapidità dei cambiamenti. E se la velocità non può essere un valore in sé, tanto meno lo sono la lentezza e l’immobilismo.
Ecco perché riportare l’asse a Roma, dal mio punto di vista, ha senso. La TAV, le grandi opere, le infrastrutture vanno decise a livello nazionale. L’Italia non è così grande da avere bisogno delle ampie autonomie concesse a stati come l’India, dotate di quello che in ambito accademico si definisce “federalismo con tendenze centripete” o gli USA (un “federalismo con tendenze centrifughe”). Mancano una storia imperiale e una grande narrazione nazionale, ed è – non dimentichiamolo – la terra del campanilismo. Tradotto: da noi ognuno fa quello che vuole. Passi l’autonomia su materie secondarie, ma siamo sicuri che la politica energetica possa essere decisa dalle Regioni a colpi di ricorsi? O che una ferrovia che va da Lisbona a Istanbul possa essere bloccata dalle proteste di un gruppo di cittadini agguerrito, ma ridotto? Le istanze locali vanno rispettate: ma non si può sacrificare l’interesse di tutti nel nome del particolarismo. Di una visione chiara dell’interesse del Paese, e della possibilità di applicarla, godremo tutti.
LE ALTRE QUESTIONI: QUORUM E CNEL – Le altre questioni poste dalla riforma Boschi sono, a mio avviso, di minor rilevanza.
C’è l’innalzamento del quorum per presentare un disegno di legge di iniziativa popolare, portato da 50.000 a 150.000 firme. La ragione? Negli anni ‘40 per raccogliere 50.000 firme ci volevano settimane, per non dire mesi: oggi potrebbero bastare tre ore, con il know how giusto e la tecnologia informatica. Si rischia un paese ostaggio del movimentismo, dei contrari a tutto, di chi vuole discutere ogni proposta all’infinito. E’ davvero sbagliato intervenire?
L’abolizione del CNEL, organo di rilievo costituzionale, invece, mi sembra, invece, solo una mossa propagandistica nel clima anti-casta di questi anni. Meno poltrone, meno spese, ragionamento buono da dare in pasto ai giornali. Probabilmente, il CNEL ha fatto meno danni di chiunque altro, ma sarà sacrificato sull’altare della retorica. Non penso ne sentiremo la mancanza, come non ci siamo mai accorti che esistesse. I dati statistici raccolti in un settantennio, però, almeno quelli, vale la pena di conservarli. Che se ne trovi la maniera: allo Stato non manca certo il personale.
LE RAGIONI DEL SI – Smetto per stanchezza. Un parere schietto. Credo che la riforma di Renzi non sia cattiva, e voterò un “sì” convinto. Ovviamente, non è neanche la migliore possibile. Ma la perfezione non esiste. Si può sempre fare meglio: ma cominciamo a rimboccarci le maniche, e a fare la nostra parte informandoci e dimostrando, nel quotidiano, quel senso civico che renderebbe inutile molta della burocrazia che ben conosciamo.