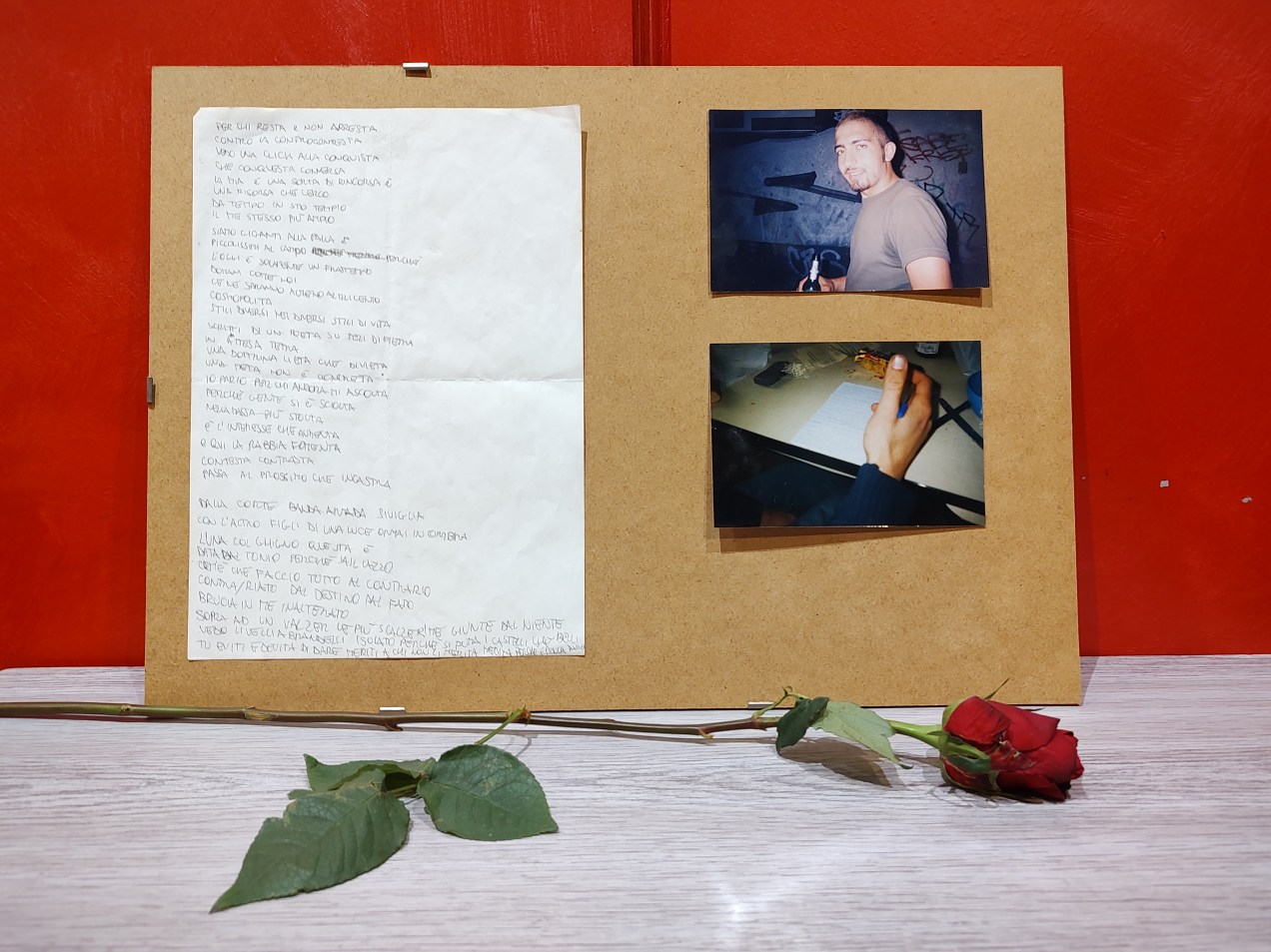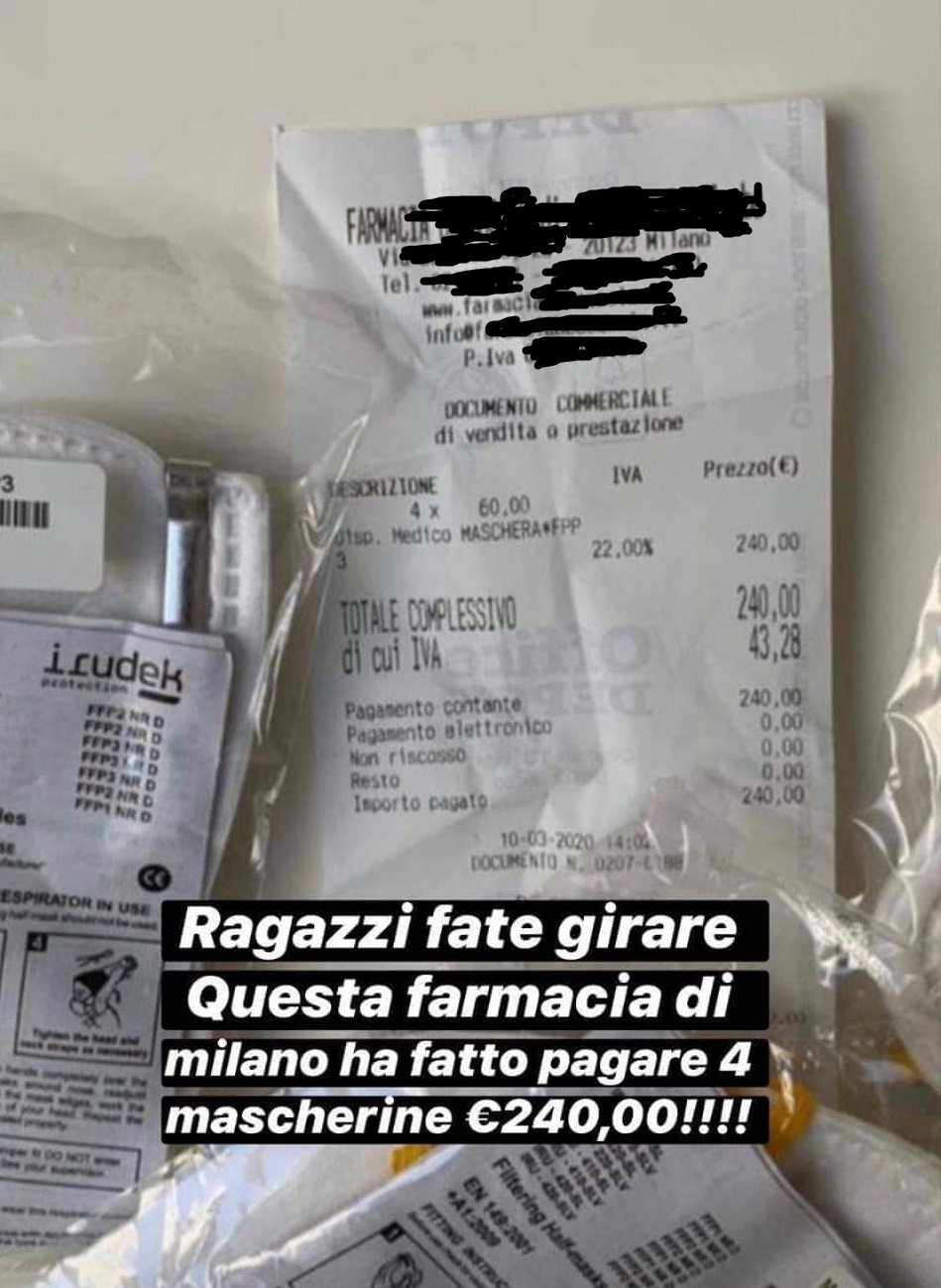Non è che l’inizio. I fatti di Milano, con gli scontri e l’assalto alla Stazione centrale, hanno oscurato buona parte delle proteste pacifiche per Gaza di lunedì 22 settembre. La stampa, anche internazionale, ha fatto fatica a distribuire i pesi. Anche a distanza di ore. Ricevo diverse newsletter, e ho particolarmente apprezzato quelle (un nome su tutti: Good morning Italia) che hanno titolato sul buono della piazza di ieri: grande, partecipata, sacrificata (non solo per il meteo, ma anche perché trattavasi di sciopero, e chi c’era rinunciava alla giornata di paga). La foto qui sopra è stata scattata nei luoghi della guerriglia, pochi minuti prima: non ci sono black block, perché la manifestazione è stata pacifica, e molto meno aggressiva di tante altre di questi anni, negli slogan e nell’atteggiamento.
Non è che l’inizio, perché ieri tanti sono tornati a casa e si sono sentiti dire: “Visto, te l’avevo detto, ma lascia stare, chi te lo fa fare”. E poi il commento peggiore, quello buono per tutte le stagioni: “Non serve a niente”.
La realtà è diversa. Prendere le strade in maniera pacifica serve, eccome. La protesta di ieri sarebbe finita sui media di tutto il mondo anche se non ci fossero stati gli scontri: ci sarebbe solo finita in maniera migliore. Guardiamo i portuali di Genova, che da mesi si danno da fare per impedire il transito di merci per Israele e carichi di armi.
Per bloccare un paese non serve distruggere una città: basta incrociare le braccia. Basta sedersi per terra, come insegnano da anni gli attivisti del clima, memori della lezione di chi ha protestato prima di loro.
Disaccoppiamo la violenza dalla visibilità: le cose, anche sui media, non funzionano così. Anzi. Si passa per delinquenti, si distrugge in poche ore quanto seminato per anni. E bisogna saperlo.

Ho letto a sinistra analisi che rimarcavano come la polizia abbia manganellato. Inutile girarci intorno: ci sono casi in cui il ricorso alle maniere forti è giustificato. E chi decide di vandalizzare una città, se non è un, passatemi il termine, cagasotto, deve accettare il rischio di prenderle. Questi pusinllanimi di quart’ordine, aggressivi a parole e nei fatti, e poi pronti ad andare a piangere a favor di telecamera mostrando le ferite fanno il gioco di chi non vuole mollare Nethanyahu, in questo caso, come il governo italiano; e, più in generale, di chi si oppone al cambiamento.
Non è che l’inizio perché chi c’era in piazza deve tornarci, senza lasciarsi scoraggiare dalla cattiva pubblicità. Bisogna isolare i violenti, diluire il ricordo di quanto accaduto con dieci, cento nuove piazze e iniziative, colorate e pacifiche. Con azioni di disobbedienza civile, scioperi bianchi, boicottaggi: c’è un campionario ricco cui attingere.
Le infatuazioni durano un battito di ciglia, e chi distrugge non ama una causa piuttosto che un’altra: protesta a prescindere. Per disagio, narcisismo, vanagloria. A volte anche perché prezzolato. E’ probabile che ieri vi fossero dei provocatori, non molti, seguiti a ruota da una manica di imbecilli privi di qualsiasi capacità di analisi, e a cui non pareva vero di avere un lasciapassare.
La parte buona della piazza di ieri deve tornare sulle strade, e farlo presto. Il momento è cruciale: c’è l’anniversario del 7 ottobre, l’assalto finale a Gaza City. C’è da immaginare il futuro della Striscia, senza America e senza Israele. I tempi della diplomazia sono lunghi, ma la soluzione a due Stati, se non diventa un alibi per l’inazione, è il primo passo, e va sostenuta, ora che è vicina. Diluiamo la violenza dei professionisti della protesta con la continuità della passione civile dei molti. E continuiamo a sacrificarci per combattere questo genocidio orrendo. Noi, che nel mondo proviamo ancora a cercare la bellezza, nonostante i nostri problemi, le nostre ansie, le nostre difficoltà. Nonostante questi tempi grami.