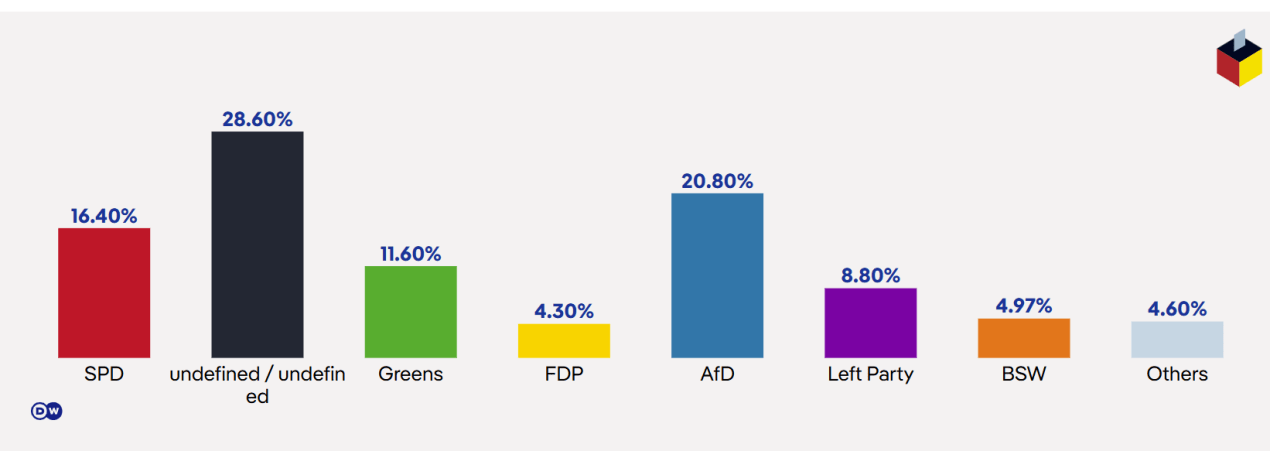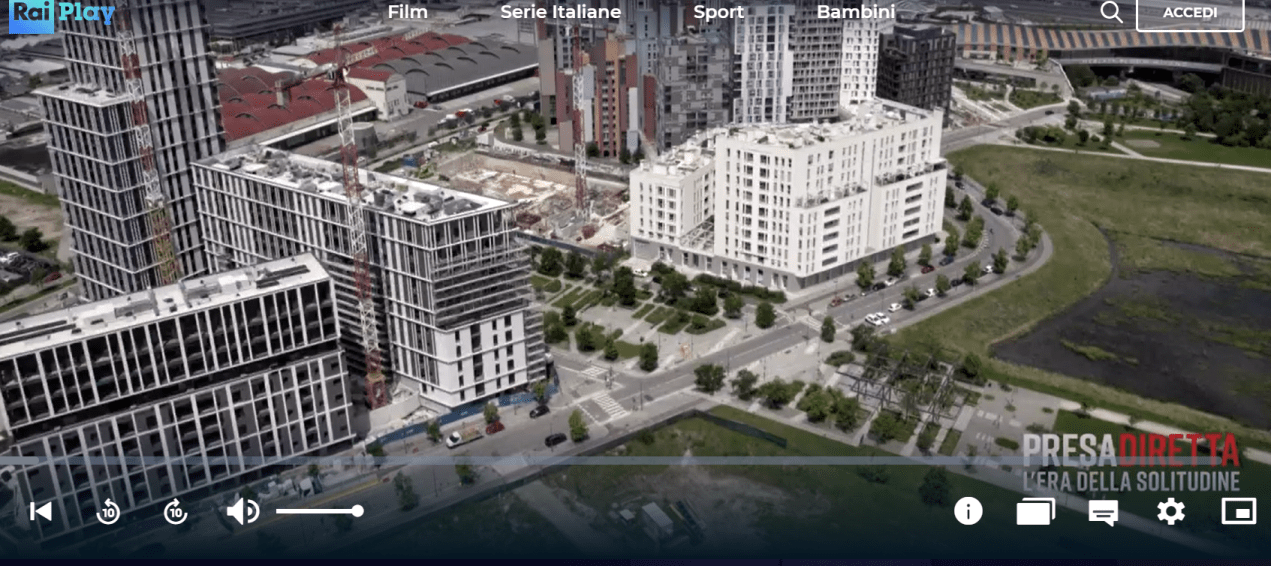Li ho conosciuti in questi anni passati in giro per il mondo a seguire conferenze sul clima, le Cop: da Glasgow a Sharm El Sheikh, da Dubai a Baku loro c’erano, cellulari e pc alla mano, per raccontare quello che accadeva. Sono giovani, svegli, preparati. Soprattutto, lavorano bene sui media digitali per portare a un pubblico ampio i temi del cambiamento climatico – quello che in ambito universitario viene chiamato disseminazione della conoscenza: perché la ricerca non basta, se non impara a uscire dai corridoi degli atenei.
L’associazione è Change For Planet, e per la Cop30 di Belém (Brasile, in scena a novembre) ha pensato di girare un documentario che racconti le contraddizioni dello Stato sudamericano. “Nel cuore pulsante dell’Amazzonia, tra Belém e Manaus, seguiremo il cammino di giovani attivisti e attiviste dall’Europa e dall’America Latina, uniti a ong e comunità indigene che ogni giorno affrontano, vivono e combattono gli effetti della crisi climatica”, dice la presidente Roberta Bonacossa. Un lavoro ambizioso e indipendente, per raccontare gli aspetti meno mediatici dell’appuntamento.
Hope, questo il nome del progetto, sarà finanziato da un crowdfunding. Aiutarlo con un piccolo contributo è un’idea da considerare (qui ci sono tutte le informazioni per farlo): Change for Planet ha svolto un ottimo lavoro in questi anni, e merita la chance di salire sull’aereo per il Sudamerica. L’opera di divulgazione che l’associazione ha portato avanti non ha padrini compromessi con il mondo delle fonti fossili ed è ritenuta da molti giovani più affidabile (non a torto) di quella di tanti giornali.
Ma la scelta di finanziare questi ragazzi ha anche il senso di farli crescere come professionisti, consentendogli di lavorare a un progetto strutturato e più ambizioso di quelli realizzati finora. La Cop30 brasiliana sarà una conferenza mediatica, preparata per Instagram e per catturare like, e c’è bisogno di voci alternative, fuori dal coro. In bocca al lupo.