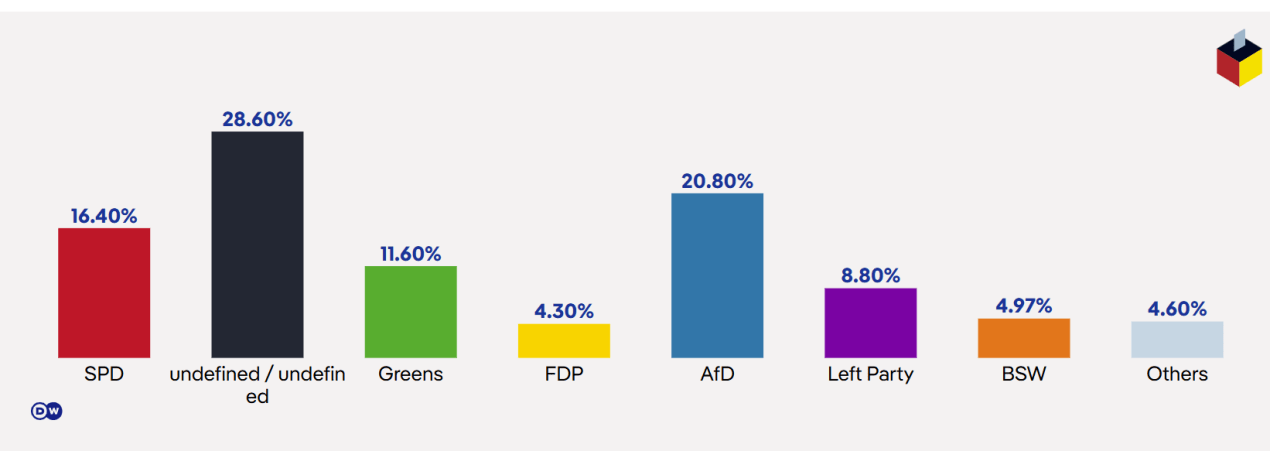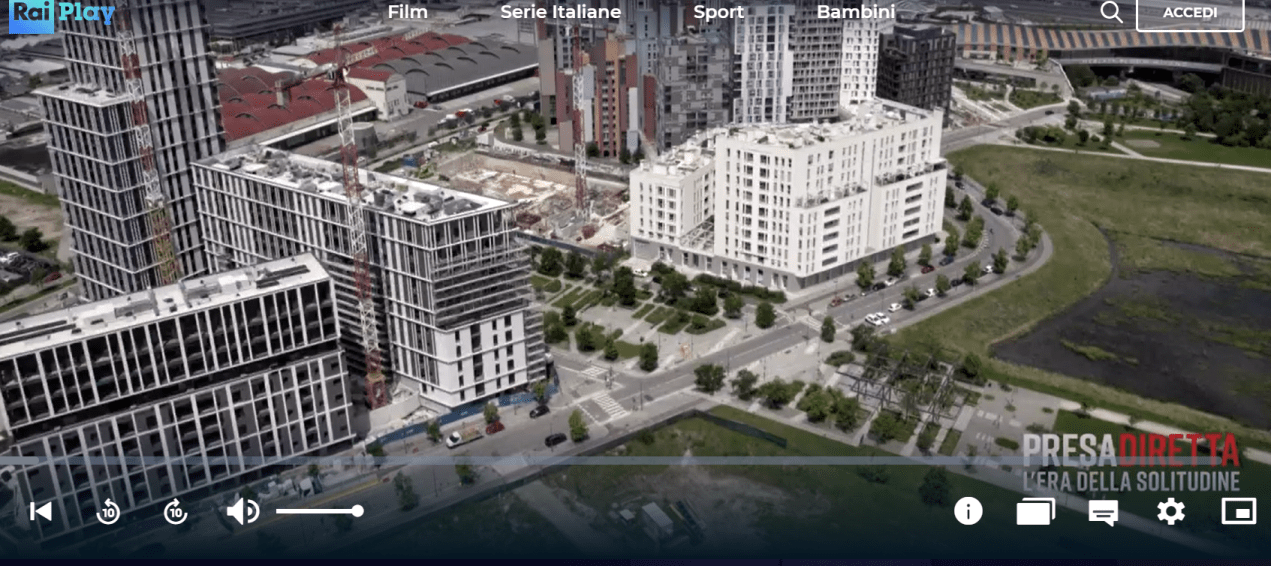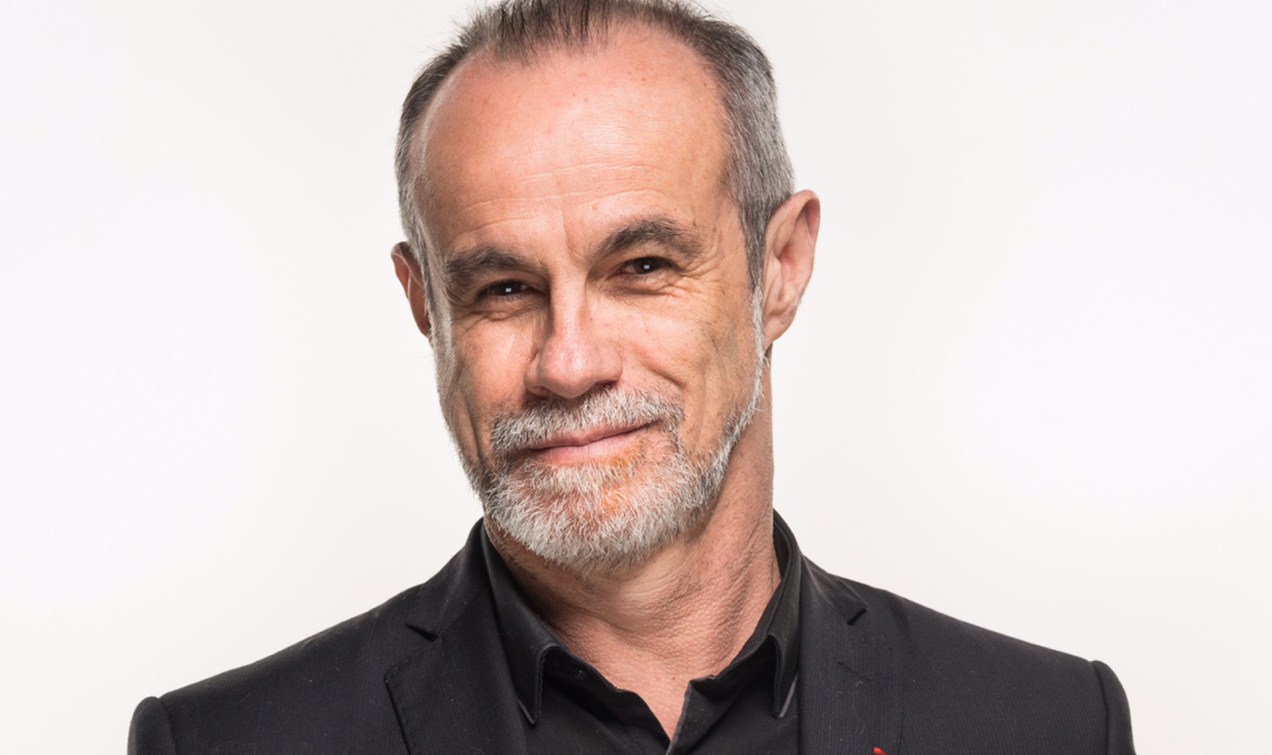Il Consiglio di Stato ha deciso: è possibile definire “green” anche un carburante. Il caso riguarda Eni, multinazionale italiana dell’oil and gas; la comunicazione della sentenza è arrivata l’altro giorno dopo una vicenda durata quattro anni, ed è stata accolta “con sodisfazione” dal cane a sei zampe.
La suprema corte amministrativa, afferma l’azienda, “ha accertato che nessuna pratica commerciale scorretta è stata messa in atto da Eni ai danni dei consumatori, e che gli addebiti a suo tempo mossi dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e il Mercato) sono da ritenersi infondati, disconoscendo il principio secondo cui termini quali ‘green’ e simili non possono mai essere associati a prodotti considerati, per loro natura, “non a impatto zero“. Del resto, alle stazioni di rifornimento abbiamo da decenni la benzina “verde”. O no?
Così prosegue la multinazionale, che ultimamente appare come sponsor anche in Festival culturali come quello della letteratura di Mantova, in una nota diffusa a margine:
“Il Consiglio di Stato ha integralmente accolto il ricorso di Eni nel procedimento con il quale la società era stata condannata al pagamento di una sanzione di 5 milioni di euro. L’AGCM nel 2020 aveva contestato la valorizzazione in termini di beneficio ambientale della componente green costituita dalla percentuale di HVO (biocarburante idrogenato) miscelata nel diesel. Con la sentenza del Consiglio di Stato si chiude una vicenda che ha causato a Eni un rilevante danno economico nonché reputazionale, avvalorando ingiuste accuse di ‘greenwashing’ che ora si rivelano totalmente infondate“.
In realtà, la “benzina verde” cui siamo abituati è un reliquato degli anni Ottanta, quando era necessaria per utilizzare le prime marmitte catalitiche e distinguerla da quella classica, che di conseguenza prese a essere chiamata colloquialmente”rossa”.
Quasi mezzo secolo dopo, pare proprio che si tratti di una distinzione superata. E che sia, piuttosto, un grosso regalo alle società che estraggono idrocarburi.
Il fatto è che è acclarato dalla scienza che il riscaldamento globale cui stiamo assistendo è di origine antropica: e, per dirla in parole povere, non è il caso di alimentare dubbi al riguardo, accostando colorazioni e aggettivi che richiamano la sostenibilità ai combustibili fossili.
Ma, secondo il Consiglio di Stato, le cose non stanno così: “Non può dubitarsi – scrivono i magistrati – in linea di principio, della legittimità dell’impiego di claim ‘green’ anche in relazione a prodotti (come nel caso di specie un carburante diesel) che sono (e restano) in certa misura inquinanti ma che presentano, rispetto ad altri, un minore impatto sull’ambiente”. Insomma, liberi tutti. Eppure, cinque milioni sono una sanzione minuscola per i bilanci di Eni. E quanto alle accuse di greenwashing, si è già detto che sempre più spesso si vede l’azienda presenziare a eventi culturali di grande prestigio. Forse i magistrati intendevano suggerire che sarebbe più appropriato parlare di bookwashing.
Secondo il Guardian, negli ultimi sette anni l’80% delle emissioni carboniche è stato prodotto da sole 57 aziende globali, tra cui l’Eni. Il conteggio(effettuato dagli scienziati di Carbon major database, che tengono un archivio specializzato) è stato avviato nel 2016, all’indomani dell’accordo di Parigi sul clima. Petrolio, gas, cemento: alcune sono private, altre controllate dagli Stati o a capitale misto. E la quota di quelle in cui sono proprio i governi a investire (come il gigante italiano) è aumentata nel tempo, impennandosi tra il 2000 e il 2010 (all’indomani del protocollo di Kyoto) e, ancora, dopo il 2016.
Invece di diminuirla, dice Carbon Major, la maggior parte delle società ha espanso la produzione dopo l’accordo firmato nella capitale francese a metà del decennio passato, quello che ha segnato una svolta nelle politiche climatiche.
E intanto, mentre estraggono, raffinano e vendono carburanti “green”, le multinazionali del fossile provano a spostare il baricentro della responsabilità sui consumatoti. Così scrivono Greenpeace e ReCommon:
“Nel 2004, racconta il giornalista Mark Kaufman su Mashable, la multinazionale britannica BP – attiva nel settore dell’oil&gas – promosse uno strumento di comunicazione che ha (purtroppo) avuto nel tempo uno straordinario successo. L’azienda, spiega Kaufman nella sua inchiesta, presentò in quell’anno ‘il suo ‘calcolatore dell’impronta di carbonio’, in modo che si potesse valutare come la normale vita quotidiana – andare al lavoro, comprare cibo e viaggiare – sia in gran parte responsabile per riscaldamento del pianeta’.”
In pratica, si è cominciato a cercare deliberatamente di convincere il cittadino che modificando il proprio stile di vita, per esempio usando i mezzi pubblici qualche volta in più, avrebbe dato un contributo decisivo a salvare il pianeta in fiamme. In parte è senz’altro vero; ma i tempi sono biblici, e non è quello di cui abbiamo bisogno. Non solo.
Diversi studi dimostrano che le simpatie ecologiste dei consumatori raramente si traducono in comportamenti di acquisto coerenti: la situazione pare stia migliorando, ma non c’è corrispondenza netta: in pratica, davanti al carrello della spesa o alla vacanza low cost dall’altra parte del mondo, siamo molto meno ecologisti di quanto ci piaccia credere. Inconsciamente, ci dimentichiamo dei nostri convincimenti. Su questa divergenza qualcuno ha anche costruito delle app, vendute ad aziende che vogliono rifarsi il belletto. Ma sono dettagli, e in fondo è business.
Sono le imprese, ed è qui il punto, ad avere la responsabilità di cambiare i propri modelli di business per trovarne di più sostenibili. Guidate come sono da consigli di amministrazione esperti, hanno gli strumenti per la transizione; invece, spingono al massimo finché è possibile, perché hanno compreso che il vento sta davvero cambiando.
lIl dibattito (anche quello, se mi perdondate la battuta) è inquinato. Non aiuta la poca chiarezza da parte dei policymaker. Come raccontavo su Wired, la Corte dei Conti europea ha recentemente bastonato i politici di destra e sinistra per le banalità – quando non proprio frottole – che raccontano agli elettori sul clima. Per esempio, il passaggio alla mobilità elettrica fosse a costo zero (dimenticano le infrastrutture necessarie e non ancora pronte, i costi ambientali dell’estrazione e molto altro, come l’indotto dell’auto a motore endotermico, fondamentale per tante persone); ma anche il fatto che i test sulle vetture elettriche sono condotti male. Quasi un electric gate, per chi ricorda il tragicomico Dieselgate della Volkswagen, con le centraline taroccate perché le auto performassero meglio in termini di emissioni quando si accorgevano di essere sui banchi delle officine di valutazione.
A condire quest’insalata amara ci si mette, da par suo, il simpatico meloniano Pietro Fiocchi, erede dell’omonima famiglia di produttori di cartucce da caccia. Fiocchi ha riempito Milano di gigantografie sponsorizzando la propria candidatura al Parlamento europeo, e, nel farlo, se la prende con l’attivista Greta: “Miss Thunberg, go back to school” dice con aria da maestro e tanto di occhiali. Non avendo spiegato cosa intende fare in alternativa rispetto a chi ha avuto il merito di rendere comprensibile la crisi del clima, il consiglio che viene da dargli è che si metta a studiare lui.
Foto di Gerd Altmann da Pixabay