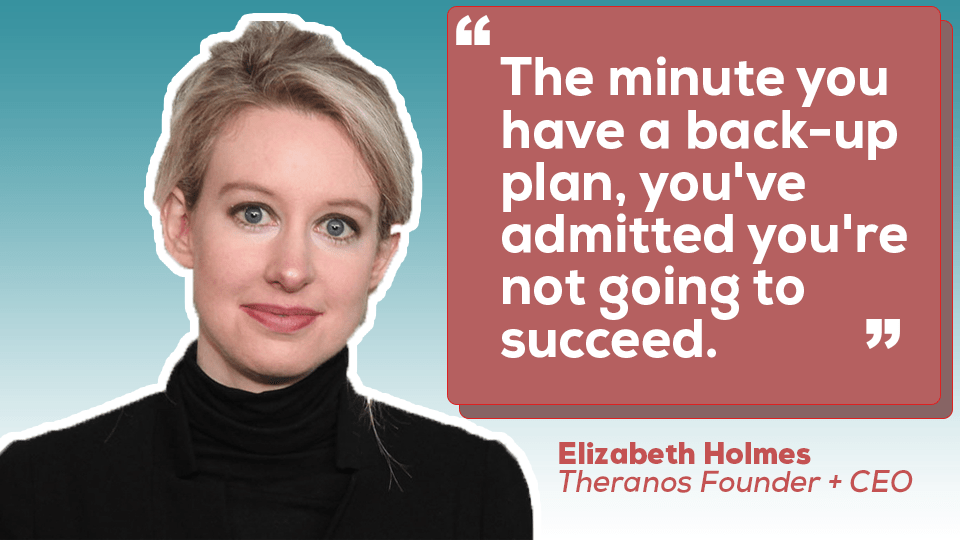Questo articolo è stato pubblicato su StartupItalia.
Un milione di metri quadri, un ospedale d’eccellenza, un centro di ricerca avanzato sulle malattie degenerative e un campus universitario da 20mila studenti. E poi startup, aziende affermate, sinergie. Milano Innovation District – l’acronimo è MIND – è il dopo Expo che il capoluogo lombardo aspettava. Vediamo cosa accadrà nell’immensa area ai confini con Rho lasciata libera quattro anni fa.

Expo 2015: una storia tormentata con il rischio di fallire
Primo maggio 2015: mentre nelle strade della città infuriava la battaglia urbana dei contestatori, a Rho prendeva le mosse l’evento che avrebbe cambiato Milano. Sotto un cielo grigio piombo e una pioggia che poco lasciava sperare, il volo delle Frecce tricolori provava a gettare una manciata di colori nella tensione.

Ad Expo si arrivò male, come spesso accade in Italia: le infiltrazioni della criminalità organizzata e la corruzione erano state ampiamente preventivate, ma nessuno seppe – o volle – intervenire. Erano gli anni in cui il prefetto Gian Valerio Lombardi poteva sorprendere la città affermando di fronte alla commissione antimafia che “Cosa Nostra a Milano non esiste”, gli anni in cui il potere di Roberto Formigoni sembrava destinato a non tramontare.
Le inchieste della discordia
Qualche mese dopo (estate 2010) arrivò l’operazione Crimine-Infinito a smascherare l’esistenza di una locale di ‘ndrangheta anche al nord, tra la Brianza e il Milanese. E, proprio da una costola di questa inchiesta, nacque quella sulla “Cupola degli appalti” che travolse, siamo a maggio 2014, la macchina organizzativa di Expo a un anno esatto dalla partenza.
Un’indagine che destabilizzò anche la Procura della Repubblica di Milano, allora retta da Edmondo Bruti Liberati, protagonista di uno scontro senza esclusione di colpi con l’aggiunto Alfredo Robledo. Pare ci fossero state pressioni del Governo dell’epoca per non bloccare la manifestazione sul nascere, e la Procura cercò di conformarsi dilatando i tempi. Robledo non gradì, e si arrivò ai ferri corti.

Expo, nonostante tutto, si fece. Si riuscì ad aprire i cancelli – evitando una figuraccia in mondovisione – anche se non tutti i padiglioni erano pronti. Com’è andata poi, lo sappiamo. L’evento fu un successo, di portata tale da diventare sinonimo di code infinite, e il padiglione del Giappone, come il casello di Melegnano, evoca ancora attese di ore nell’immaginario dei milanesi, e non solo.
Da Expo a MIND
Ma, chiusi i battenti il 31 ottobre, si poneva il tema di cosa fare dell’area. Domanda non banale, Torino era già lì a mostrare come il patrimonio di infrastrutture costruito durante i giochi olimpici potesse essere abbandonato. Matteo Renzi, all’epoca presidente del Consiglio, si spese da subito tracciando la via. Il progetto di recupero di un’area da un milione di metri quadri prese corpo in quei giorni tra il comprensibile scetticismo di chi era abituato alle chiacchiere della politica. Molta acqua è passata sotto i ponti da allora: in pochi ci credevano, ma adesso, finalmente, si cominciano a vedere i risultati.
Un grande parco, l’Università Statale e il Nuovo Galeazzi
Il progetto di riconversione dell’area è entrato nelle fasi operative, mantenendo la vocazione originale che lo legava alle scienze della vita. Il Decumano, lungo 1500 metri, diventerà la colonna vertebrale del masterplan disegnato da Carlo Ratti, un asse da cui sarà possibile raggiungere tutte le aree. Oltre mezzo milione di metri quadri darà vita a uno dei più grandi parchi lineari d’Europa: campi da gioco, spazi di relax e perfino orti serviranno ad attirare la cittadinanza, che peraltro si è già abituata a prendere la metropolitana fino al capolinea per assistere a concerti ed esibizioni. Sono stati più di un milione in tre anni i fan in fila per artisti come Eminem e i Pearl Jam o semplicemente per ammirare l’Albero della Vita, diventato una sorta di monumento nazionale postmoderno.

Ma nel disegno trova posto il meglio della tecnologia, della ricerca e dell’innovazione italiana e internazionale. Si comincia con la creazione di un quartiere interamente driverless: veicoli leggeri senza pilota si muoveranno in uno spazio dedicato che consentirà di sperimentare soluzioni avveniristiche.

Si prosegue con il trasferimento di settte facoltà scientifiche dell’Università Statale di Milano. “Il primo studente è atteso per l’anno accademico 2024 -2025 – conferma Riccardo Capo, direttore Operations di Arexpo, la società che coordina il progetto di riconversione – Il campus, sul modello americano, servirà 18-20 mila studenti al giorno, che vivranno l’esperienza accademica a stretto contatto con le aziende in cui potrebbero, un giorno, lavorare”.

All’ateneo si aggiungerà un ospedale: il Galeazzi, storico nosocomio milanese, troverà sede qui, con un edificio da 10 piani, 600 posti letto e 8 mila utenti al giorno. Tra i corridoi, oltre a curare i malati, si farà ricerca di avanguardia in cardiologia e ortopedia. Questa tranche di progetto sarà finanziata da una cordata mista: 1,8 miliardi provengono dal settore pubblico, mentre il privato contribuirà con i 2 miliardi che si è impegnata a versare Lendlease e i 300 milioni di euro del Gruppo San Donato. Lendlease pagherà, inoltre, un canone di concessione di 671 milioni di euro in 99 anni. Il cantiere è già avviato, le ruspe si muovono per completare i lavori entro il 2021.

Human Technopole: ricerca di eccellenza su Parkinson, Alzheimer e cancro
Il fiore all’occhiello del progetto è, però, Human Technopole, centro d’eccellenza. “Vivere a lungo è diverso da vivere bene” potrebbe essere il concept di questa piattaforma orientata alla ricerca ad ampio spettro sull’essere umano del Duemila. La sede è a Palazzo Italia, a pochi passi dall’Albero della Vita, il focus sulle malattie degenerative come Alzheimer e Parkinson e su quelle tumorali. I soldi ci sono – 1,2 miliardi già stanziati con la finanziaria del 2016, i lavori sono in corso: oggi apre il terzo cantiere, mentre il primo manipolo di ricercatori (400) arriverà nell’estate 2020: saliranno a 1500 quando l’ente funzionerà a pieno regime.

“Sarà un hub con cui metteremo la tecnologia più avanzata a disposizione non solo dei nostri scienziati, ma di tutti quelli che ne faranno richiesta, naturalmente dietro presentazione di un progetto” spiega Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole. Trentamila metri quadri, sette centri di ricerca e due grandi microscopi alti dieci metri per esplorare la materia fino alle strutture atomiche delle proteine, per poi passare dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande grazie a elaboratori dalla potenza mai sperimentata nel nostro paese.
Leggi anche: Italia al 25esimo posto nel ranking di Startup Blink
“Oggi il risultato finale di una ricerca arriva a valle di una grande fase di raccolta di dati, che vanno inseriti in modelli matematici, i quali vanno, a loro volta, interpretati – spiega il manager – Gli stadi finali di questa operazione vengono gestiti al computer da scienziati computazionali”. Perché oggi l’informatica si è infilata anche qui, dove prima si smanettava con provette e becher.

Non può mancare un occhio di riguardo al trasferimento tecnologico, alla creazione – cioè – di best practices per passare dal laboratorio al mercato. Non solo. Il know how raccolto verrà sottoposto ai policy-makers, sempre alla ricerca di soluzioni per mantenere uno stato sociale che, con l’allungamento della vita media, è sempre più difficile da sostenere.
Tante le grandi società interessate all’area…
Veniamo alle imprese. Di questo parte del progetto si occupa la società australiana Lendlease. Una settantina di grandi aziende hanno manifestato interesse a insediarsi nell’area, ben collegata da mezzi di comunicazione (metropolitana, treno, autostrade) e vicina a zone di nuova edilizia residenziale dove i futuri dipendenti possono, eventualmente, trovare alloggio. Tra queste IBM, Intesa, Novartis e altri nomi di punta del firmamento internazionale.
…Anche startup
Ma ci sono anche le startup: una call chiusa a febbraio ha registrato 118 richieste da parte di aziende sulla frontiera della tecnologia. “Circa il 50% si occupano di smart city e digital, segno che l’area è al passo con le tendenze globali – riprende Capo – Molto interesse abbiamo riscontrato anche nei settori cultura, scolastico ed entertainment, con un 20% circa delle proposte”.
Leggi anche: Expo, 3 anni dopo | Giuseppe Bonomi (Arexpo): “Qui sorgerà il Milano Innovation District”
L’area, a regime, ospiterà 60mila persone al giorno. Nei prossimi cinque anni si raggiungerà la metà delle presenze previste. Le premesse per creare un altro successo ci sono tutte; ma con le aspettative che si sono alzate, la delusione per un eventuale fallimento può essere ancora più cocente.
Leggi anche: Expo, cosa è successo dopo la chiusura della fiera
I rischi sono i soliti. Corruzione, appalti, bonifiche mai fatte o fatte male. Grandi aree hanno sempre stimolato ingenti appetiti, controlli farraginosi, mazzette. La storia di Expo insegna che le Cassandre in Italia non parlano quasi mai invano. Molta acqua è passata sotto i ponti rispetto a dieci anni fa. Milano ha saputo lanciarsi all’inseguimento delle migliori capitali europee. La città conosce un fermento e un vigore che non si registravano dal boom economico, ma augurarsi che tutto vada bene non basta. Bisogna stringere le maglie dei controlli per evitare che un patrimonio nazionale come quello del post Expo venga disperso. Milano, l’Italia, non possono permetterselo.