L’intervento è finito. Ventitré ore sotto i ferri. Non si sa se ce la farà, ma per il momento è vivo. Uno scatto, solo uno, per rendere la fatica, la concentrazione, i nervi tesi di Zbigniew Religa, cardiochirurgo polacco che operava in condizioni da terzo mondo durante gli anni bui del comunismo. La luce artificiale, gli schizzi di sangue, i tubi, il camice sporco e la maschera ancora sulla bocca. E quell’assistente distrutta in fondo alla sala, che si butta contro il muro per dormire esausta il sonno dei giusti. Ci sono immagini che vanno al di là dei luoghi, fotografano un’epoca. La foto dell’americano James Stanfield è una di queste. La precarietà, lo sforzo fisico e mentale, la scarsità di mezzi. Era il 1987. Il paziente, per la cronaca, sopravvisse al chirurgo, morto nel 2009.

American Pastoral
America, anni ’60. La storia dello Svedese, il prototipo del vincente a stelle e strisce, prima dell’era di Wall Street. Kalos kai agathos, come dicevano in Grecia, quando alla bellezza del fisico si accompagna quella dell’animo. Una personalità semplice, ingenua, baciata dalla vita, colpita dall’invidia degli dei. Mentre il ’68 scuote il mondo dalle fondamenta, lui si ritira in campagna per non sentire, tornando in città solo per lavorare nella sua fabbrica di guanti. Si costruisce una vita perfetta, sposa una reginetta di bellezza, si rifugia nella quiete bucolica assieme alla moglie, che aveva altre ambizioni. Ma la campana di vetro non regge all’urto. Finirà solo in mezzo a tanti, consumato da un dolore sordo. Alla fine sarà il più forte di tutti a rivelarsi il più debole e fragile. Il campione che eccelleva nello sport, dove le regole rendono la pugna prevedibile, crolla nella lotta da strada, quando i colpi arrivano da tutte le parti, senza un ordine. E senza regole a premiare i buoni.
Passione e bontà d’animo non bastano, al di là della retorica: questo il messaggio di Roth. La realtà è molto diversa. E intanto l’America va avanti, come sempre, col pragmatismo che le impone di lasciare indietro chi non ce la fa.
Ewan Mac Gregor è stato bravo a rendere un romanzo complesso, semplificandolo (lo scrittore è prolisso, può piacere o meno, ma è il suo stile). Niente male come prima prova di regia, fotografia ottima, scenografia e costumi più che all’altezza. Musiche adeguate. Il film tocca, senza eccedere nell’introspezione come sarebbe stato sin troppo facile.
La storia della figlia dello Svedese e di Dawn mi ha ricordato Lilly di Venditti, una delle canzoni più belle del repertorio italiano. Per strade diverse, i due autori declinano lo stesso concetto: i tormenti di un’anima debole e inadatta a reggere la pressione sociale, il conformismo. Facile passare dalla parte del torto.
Pastorale americana è un film che rivedremo sicuramente a notte fonda su Retequattro, un piccolo cult destinato a sopravvivere alla stagione cinematografica. Merita.

Brexit, cosa vuole davvero Theresa May?
Non l’avesse May detto. Il gioco di parole rende il clima attorno a Downing Street dopo le rivelazioni del Guardian di stamane. Il quotidiano ha riportato un discorso della premier britannica tenuto a maggio di fronte alla platea di Goldman Sachs. L’allora ministro dell’Interno, oggi dura nei confronti dell’Europa, si schierava decisamente a favore del Remain.
Nel corso dell’intervento, May avvertì sulle possibili conseguenze della Brexit per le imprese britanniche, sottolineando che molte aziende avrebbero potuto spostarsi sul continente in caso di uscita dal mercato unico. Il settore finanziario era, ovviamente, in prima fila. Non è la prima volta che la banca d’affari americana invita politici in carica per incontri a porte chiuse destinati a creare imbarazzo: nel 2013, Hillary Clinton tenne un discorso riservato nel quale si mostrò parecchio morbida nei confronti di Wall Street. Una contraddizione con la politica attuale che Wikileaks ha riferito nei giorni scorsi nel tentativo di screditarla.
La coerenza, si sa, in politica può diventare un peso, e alla bionda inquilina di Downing Street è toccato lo stesso destino. In un altro intervento, risalente ad aprile, May rivelava che il controllo dell’immigrazione non le sembrava una priorità rispetto alla permanenza nel mercato unico. Strumenti comunitari come il mandato d’arresto europeo – sosteneva – erano, anzi, armi adeguate a fronteggiare il problema degli irregolari.
Che cosa sia cambiato è difficile dirlo. Al suono dello slogan “Brexit means Brexit”, May ha sostenuto, in proprio o per interposta persona, posizioni molto dure sul tema, probabilmente con l’intento di alzare la posta per trattative che si annunciano difficili.
Nel gioco di specchi delle statistiche, serve una certa conoscenza dell’economia politica per capire cosa stia realmente accadendo in UK dopo il 23 giugno. Il crollo della sterlina, l’indicatore più citato, dice poco. Inizialmente, anzi, favorisce le esportazioni, drogando l’economia come facevano le svalutazioni della lira.
Un esempio può servire a spiegare le variabili in gioco. Settore aeronautico. I profitti della compagnia low cost Easyjet sono scesi per la prima volta dal 2009 nell’anno fiscale chiuso il 30 settembre: un calo del 28% rispetto al 2015, dovuto all’impatto del terrorismo sui voli turistici a corto raggio e ai costi fissi come, ad esempio, quello del carburante (pagato in dollari) o dei servizi aeroportuali (pagati in euro). Il rischio di cambio ha giocato, in questo caso, a sfavore del vettore basato a Luton. Una tragedia, se non fosse che, parallelamente, i passeggeri hanno registrato un aumento record grazie ai biglietti meno cari. Il risultato è un calo contenuto, che però nasconde insidie: 495 milioni di sterline di profitti contro i 516 attesi sono una differenza trascurabile, ma i numeri vanno interpretati e dietro alle dichiarazioni di facciata, i dirigenti di Easyjet sanno che il momento non è favorevole.
Lo stesso effetto si verifica grossomodo nell’economia reale. Londra, una delle città più care al mondo, sta tornando ad essere una meta conveniente per i turisti europei e americani, e non manca chi rifà la fornitura di computer aziendali comprando quelli dismessi dagli uffici dalla City: mai stati così convenienti. Ma se turismo ed esportazioni contribuiranno a far girare l’economia, le importazioni peseranno parecchio. I primi effetti potrebbero mostrarsi nel settore dell’energia, dove i prezzi sono espressi in dollari. E con il petrolio così basso, un aumento improvviso del prezzo del barile potrebbe costare molto caro, in tutti i sensi, a partire dall’inverno.
Il diavolo sta nei dettagli, e il castello di retorica comincia a scricchiolare. Nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato un adeguamento delle tariffe nel Regno Unito. Il colosso di Redmond aumenterà il costo dei propri servizi business e cloud sul modello di quanto già avvenuto in Svizzera e Norvegia (dove circolano, rispettivamente, il franco e la corona). I prezzi sono destinati a salire fino al 22% a partire dal primo gennaio 2017: pressappoco quanto è calata la sterlina rispetto all’euro.
Nei piani strategici delle aziende, la Gran Bretagna è legata a doppio filo all’Europa, e Microsoft è solo la prima di una serie di compagnie che saranno costrette a cambiare. Gli effetti non sono calcolabili.
Nessuno, al momento, sa cosa accadrà. La Brexit come ce l’eravamo immaginata non è ancora avvenuta. L’articolo 50 del Trattato europeo non è stato attivato da Downing Street, e la data continua a slittare. Le stoccate nei confronti dei cittadini Ue residenti sul suolo inglese lasciano intendere che il governo voglia usare i loro diritti come merce di scambio al tavolo delle trattative. Ed esiste l’ipotesi che, calmati gli animi, si stia lavorando a una exit strategy che dia l’impressione di salvaguardare l’esito del referendum. Ma che, al contempo, ne eviti gli effetti disastrosi. (foto: The Independent)
Antonio Piemontese
@apiemontese
(L’articolo originale è uscito su Londra, Italia del 26 ottobre 2016)
Milano saluta Dario Fo
Scroscia la pioggia, cappotti bagnati. I funerali sono eventi tristi. Ce ne sono di baciati dalla sorte, con il cielo che accompagna le parole e infonde speranza. Non e’ il caso di Dario Fo. A Milano un ticchettio incessante puntella ombrelli e impermeabili.
Il seguito che ha accompagnato l’attore in vita, nascosto fino a ieri nelle case sotto i maglioni di inizio autunno, emerge come un fiume carsico. Fo, semplicemente, non c’e’ piu’, e al cuore manca un pezzo. 
E’ il popolo di chi conosce la fame, il dolore, la fatica di vivere e non riesce a convincersi che le carte non siano truccate. Di chi la mattina si alza dal letto per i figli, piu’ che per se stesso. Di chi ha il fiato grosso per la rabbia di vivere in una societa’ sempre piu’ lontana dai bisogni primari, in cui la forbice tra chi ha troppo e chi non possiede nulla si allarga senza pieta’. Fo non ha mai perso la capacita’ di ascoltarne il lamento. La sua opera teatrale, come ha ricordato Carlo Petrini nella splendida orazione funebre, e’ inscindibile dalla politica, perche’ il suo teatro nasceva dalla vita. Quanto fosse importante per Milano si legge nelle lacrime che sciolgono il rimmel di signore attempate e ragazze ancora giovani. Si intuisce dalla strana assenza di fotografi da cellulare, normalmente attenti a immortalare ogni cosa.
Ci lascia un altro gigante. Ho assistito ai funerali di Umberto Eco, a febbraio. Per quanto la cultura del professore piemontese abbia significato per l’Italia e le migliaia di persone che si sono recate al Castello Sforzesco a salutarlo, Eco era un intellettuale d’accademia e d’osteria. A Fo, e lui sarebbe contento di sentirlo, dell’accademia non fregava niente. Era l’amico a cui e’ andata meglio, che non dimentica chi e’ rimasto indietro, quello che ti ascolta, non ti da’ consigli, ma spende un’ora – o una vita – per farti ridere e ricordarti che dietro alla maschera di un sorriso puo’ esserci il tuo stesso dolore. Una signora sotto la pioggia regge un ombrello. C’e’ scritto “allegri”, un marchio come tanti. Rivoli d’acqua lo lambiscono, e scivolano a terra. Come a dire, anche il dolore passa.

Sicko, o della fortuna di vivere in Europa
L’articolo qui sotto è stato pubblicato in origine su TiSOStengo, ed è disponibile a questo link. Buona lettura.
Michael Moore è sempre stato un regista controcorrente. Americano fino al midollo, ha fatto della critica al suo paese il fil rouge di tutti i suoi film. Da “Bowling a Columbine” a “Fahrenheit 9/11”, passando per “Capitalism: a love story”, fino a “Where to invade next?” ha affrontato dietro alla macchina da presa tutti i temi più importanti della politica e della società a stelle e strisce. Nel 2007 Moore uscì con un nuovo lavoro, dedicato alla sanità: si chiamava Sicko, ed era destinato, come tutti gli altri, a far riflettere.
Il documentario – le opere del regista di Flint appartengono a questo genere – si apre con la storia di un falegname con due dite amputate da una sega circolare: arrivato al pronto soccorso, e verificato il tipo di copertura assicurativa di cui disponeva, i medici gli chiedono di scegliere quale delle due riattaccare. “Ho scelto l’anulare, per tenerci l’anello del mio matrimonio” confesserà lui; la verità è che costava molto meno del medio.
Benvenuti negli USA, dove le assicurazioni sanitarie dettano legge, e si può essere buttati fuori da un nosocomio (patient dumping) se non si dimostra di essere in grado di pagare, lasciati in mezzo a una strada con il camicione da ricovero ancora addosso.
Quando la salute è un business, le compagnie sanitarie si appellano a ogni cavillo pur di non pagare, fino a rifiutare esami fondamentali. La figura del supervisore medico, retribuito in base a quanto riesce a risparmiare rifiutando visite e prestazioni, ha letteralmente potere di vita e di morte sui pazienti, cercando nell’anamnesi le ragioni per rifiutare la copertura: ogni ricovero deve essere autorizzato, e si dà il caso che, talvolta, qualcuno nell’attesa prenda il volo verso l’ aldilà.
Del resto, negli USA il modello europeo di sanità pubblica viene percepito come “socialista”, in omaggio alla nota allergia americana a ogni sfumatura di rosso che non sia quella della bandiera. Eppure, a pochi passi dalla frontiera, in Canada, curarsi è gratis: ma lo è anche in Francia, in UK, a Cuba, e da noi.
Ben girato, con una colonna sonora all’altezza, Moore con “Sicko” ha il merito di portare fuori dai confini nazionali una situazione che difficilmente può essere immaginata. Come al solito, calca un po’ la mano con la retorica, fino a tratteggiare un quadro di Cuba come paradiso terrestre (e infatti pare che il film sia stato vietato nell’isola: la gente avrebbe potuto agitarsi), ma è un difetto che gli si perdona volentieri.
“Sicko” va visto per ricordarci che, nonostante sia migliorabile nella gestione degli sprechi, nella formazione e selezione del personale e nello spadroneggiare della politica, il nostro modello sociale e sanitario è ancora di gran lunga superiore a quello a stelle e strisce. La salute, in Europa, è garantita a tutti, non solo a chi è ricco. Vale la pena di rifletterci ogni tanto.
(L’articolo originale è stato pubblicato su tiSOStengo del 12 ottobre 2016)

Liga Rock Park: la recensione
Ottantamila persone, una “macchia” da 250 metri visibile anche dallo spazio con un satellite a infrarossi, un boato che si è sentito a Villasanta, Vedano, Lissone, Biassono, Lesmo, e insomma in tutta la Brianza. Dopo trecentosettanta giorni Luciano Ligabue è tornato sul palco, e lo ha fatto a Monza, all’Autodromo. Un’organizzazione perfetta per un live dal suono possente, acustica generosa grazie a casse alte venti metri e una scenografia laser con maxischermo che ha permesso di vedere e ascoltare anche a chi era più distante. Gente da Sassari, da Bologna, dal Sud Italia, ma anche tanti che al concerto sono venuti a piedi godendosi la passeggiata nel Parco che della città brianzola è il simbolo.
Era attesissimo il ritorno del rocker di Correggio, che apre lancinando l’aria con la chitarra di Libera nos a malo e ripercorre venticinque anni di carriera tra rock duro e ballate acustiche.
Il concerto dura tre ore, suonate con prepotenza, qualche momento di stanca in corrispondenza dei brani dei primi anni duemila, quando l’ispirazione era (temporaneamente) volata via. Ma da qualche tempo il cantautore emiliano ha ritrovato vis poetica e chitarre, virando verso un suono più potente e vissuto. Dieci anni di purgatorio per uscirne rinato e con un sound nuovo di zecca, da vero animale del palcoscenico. La voce, quella c’è, e migliora con gli anni: mai una stecca, perfetto nell’intonazione, mai in affanno anche nei passaggi più veloci.
A fianco a lui il compagno di mille palcoscenici, Fede Poggipollini, e una band precisa e potente. Rullate di batteria mixate come tuoni, e lo schermo che accompagna il live interagendo con le canzoni. Tre pezzi dal nuovo album Made in Italy, concept dedicato a un uomo che riflette su un passato fatto di alti e bassi, ma non ha perso la voglia di vivere e godersi l’esistenza, come nella peccaminosa “Dottoressa”.
Il Parco di Monza potrà essere cornice di eventi di prestigio grazie alla capacità organizzativa mutuata dal Gran Premio. Il vialone che lo taglia in due, illuminato a giorno, si è riempito di ragazzi che si baciavano, mamme con figli e bandane annodate in testa, stremati ma felici per aver vissuto un evento unico. Esame superato per Ligabue. Nel tempio della velocità, il cronometro sembra essersi fermato a 30 anni fa.

Twitter e Yahoo: fine di un ciclo
Settimana di notizie di un certo peso per il web. Dopo la conferma che sarebbero state rubate le password di 500 milioni di account Yahoo, arriva quella che Google e Salesforce sarebbero interessate a Twitter. Vediamo di capire qualcosa di più.
Il furto di dati è stato rivendicato da un hacker, a quanto pare russo, che si fa chiamare Peace. Il mago della tastiera ha messo in vendita sul deep web (il web non accessibile con i normali browser e motori di ricerca, dove è possibile comprare di tutto, da documenti falsi a organi e persino assoldare un killer) i dati all’equivalente di 1800 dollari in bitcoin, la moneta virtuale. La faccenda assume contorni grotteschi perché Yahoo, un tempo uno dei principali player online, non ha fatto immediatamente chiarezza. Un’altra macchia per Marissa Mayer, pagatissima e bionda Ceo che si vanta di lavorare 130 ore alla settimana. Tra i primi dipendenti di Google, talento indiscutibile sul lato tecnico, la Mayer non si è mai calata nei panni della manager, fallendo il rilancio del motore di ricerca che alla fine degli anni ’90 faceva concorrenza a Brin e Page. Il passaggio a un ruolo marcatamente business non può dirsi riuscito: ma se rianimare un cadavere non è impresa da poco, resta il dubbio che le sfide, in qualche caso, sia meglio rifiutarle. Come insegnava Lao Tzu, la strategia migliore è non combattere le battaglie che si è destinati a perdere.
Nel caso di Yahoo, il distacco dai concorrenti era già abissale ai tempi dell’entrata in gioco di Mayer. Anche Microsoft ha provato a entrare nel settore, con Bing, ma il colosso di Seattle ha dalla sua la proprietà del sistema operativo più diffuso al mondo, Windows: base d’appoggio di tutto rispetto. In Usa pare che il lavoro ai fianchi stia dando i suoi frutti: se fare concorrenza a Mountain View è impensabile, si può sempre pensare di tenere botta in attesa di tempi migliori.
La notizia dell’interesse di Google e Salesforce per Twitter ha scosso il mercato: il titolo è salito del 21% in Borsa. Premesso che parliamo di impressioni, la mia sensazione è che siamo alla fine di un ciclo.
Twitter va male, lo sanno tutti. Il 2016 non è stato, come si sperava, l’anno del rilancio. I ricavi sono sotto le attese, e l’aumento degli utenti pure. Concorrenti come Instagram sono riusciti a fare di meglio.
Il problema, in questo caso, è strutturale. Twitter è un raro caso di prodotto (meglio sarebbe dire “servizio”) icona dei tempi. Un ruolo che, se conferisce enorme prestigio, non sempre si presta ad essere capitalizzato. Salito alla ribalta nel 2009, anno delle proteste in Iran, come strumento dei dissidenti per informare il mondo tramite flash brevi ed efficaci, è entrato nell’immaginario comune al punto che il cancelletto è diventato, per tutti e ovunque, hashtag: alla vecchia maniera, ormai, lo chiamano solo le voci registrate delle segreterie telefoniche. Il linguaggio di una generazione è stato tematizzato da queste parole-chiave, che rappresentano un modo di pensare veloce, rapido e per immagini: quello dei millenials, i nati dopo il 2000.
Il problema è che Twitter è rimasto quello che era all’inizio: uno strumento utile ai pochi eletti con milioni di followers, apprezzatissimo dai giornalisti che possono seguire rapidamente le storie di loro interesse grazie al limite dei 140 caratteri, ma assolutamente inutile per tutti gli altri. Le opinioni dell’uomo comune, le sentenze in formato ridotto che si postano sul social media, non interessano nessuno. E alla fine, le notizie dei “VIP” la gente preferisce ancora leggerle sui giornali, con un minimo di rielaborazione, e di contesto. A interpretare il narcisismo da selfie riesce meglio Instagram. La pubblicità non è mai decollata, e anzi, ha persino rovinato l’immagine della piattaforma, da sempre pulita; né sono servite le innovazioni proposte col tempo, sempre lontane dalla natura di un medium nato per essere conciso.
Ecco perché, sinceramente, non comprerei le azioni di Twitter. Dal mio punto di vista, il passaggio di mano significherebbe che qualcuno ha deciso di gettare la spugna. Una delle strategie più usate negli ultimi tempi è quella di inglobare i concorrenti di cui non si riesce a sbarazzarsi. Così ha fatto Facebook con Whatsapp, con l’intento non troppo nascosto di portarne gli utenti su Messenger: una piattaforma su cui Zuckerberg immagina la gente vivrà un’esperienza a 360 gradi, usandola, ad esempio, anche per fare acquisti. Così fece Microsoft con Skype e, più di recente, con Linkedin. Google potrebbe ragionare allo stesso modo e preparare sorprese: una nuova app?
Discorso diverso per Salesforce, piattaforma cloud usatissima nel settore del business development, la nuova frontiera dello sviluppo commerciale: consente, in sostanza, di gestire la propria forza di vendita in maniera coordinata, affidando obiettivi precisi a ogni agente e monitorandone la progressione e i risultati in tempo reale.
Forse in questo caso, l’utilizzo potrebbe essere quello di uno sviluppo del servizio, aggiungendo nuove funzioni a quelle esistenti (ad esempio, una piattaforma megafono per le aziende che vogliono investire in pubblicità online).
Ribadisco: si tratta di impressioni a caldo, ma sulla fine della parabola di Twitter come lo conosciamo sarei pronto a scommettere. E’ entrato come pochi prodotti (pardon, servizi) nell’immaginario collettivo, plasmando il mondo e diventando il simbolo di un’epoca. Se sopravviverà (e se il nuovo management lo vorrà) manterrà intatto il suo charme. Ma è chiaro che, nella mente di chi lo ha fondato, si tratta di una scommessa persa. C’è un che di tragico in tutto ciò: creare una delle applicazioni più famose della storia, e perdere la sfida con l’ambizione. Se la realtà non smette di annoiarci, probabilmente questi chiaroscuri ne sono il motivo.
Diritto all’oblio: subito la legge
Questo pezzo è stato pubblicato in originale su TiSOStengo.
Quando le notizie che arrivano sono queste, verrebbe voglia di spegnere il computer, il cellulare e riporre la tecnologia in una scatola con tutto il buono che ci ha regalato. Tiziana C., giovane e bella donna di Mugnano, in provincia di Napoli, si è tolta la vita a 31 anni impiccandosi con un foulard. Pochi, pochissimi, se si ha la fortuna di possedere l’essenziale: una casa, un lavoro, e un po’ di salute. Ma per la protagonista di un video sexy girato con leggerezza e spedito, per chissà quale motivo, a presunti amici, la serenità è una chimera.
Benvenuti al tempo della Rete, dove tutto ciò che passa dal web è destinato a restarci. Per sempre. Il nome di Tiziana, protagonista a volto scoperto, era circolato, aprendo la strada a pagine Facebook cariche di insulti per quell’atto frivolo di cui, poco dopo, ha compreso la stupidità.
“Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio” cantava de André. Il paese chiacchiera: la madre, dipendente comunale, si nasconde per la vergogna. La figlia, per disperazione, sceglie di cambiare città, rifugiandosi in Toscana. Non serve.
Mandare un curriculum, chiedere l’amicizia su Facebook, innamorarsi in palestra: cose normali per chiunque, non lo erano per Tiziana. Vittima del web e dei tanti voyeur che consumano gigabyte e avambracci guardando porno amatoriali, per poi lavarsi la coscienza vomitando ingiurie.
Nome e cognome avrebbero inchiodato per sempre quella ragazza di 31 anni al suo errore. Imperdonabile, in una società sessuofobica. Peccato che, mentre un foulard le portava via la vita, legioni di ladri in giacca e cravatta, politici corrotti, preti con figli bevessero Martini, come sempre, sulle terrazze del Belpaese. Aveva deciso di cambiare identità, Tiziana, rinunciando a sé per sfuggire agli avvoltoi. Ma non ha fatto in tempo a salvarsi.
Pensate non vi riguardi? Sbagliato. Nessuno è al sicuro. Le tutele sono scarse. Il diritto all’oblio, che dovrebbe garantire la cancellazione dei contenuti inattuali pubblicati sul web, è di difficile applicazione. Troppo facile copiare un contenuto e diffonderlo, riparandosi dietro server collocati chissà dove. Senza contare l’effetto Streisand: se la notizia dell’azione legale si sparge, la diffusione della notizia, paradossalmente, aumenta.
In Italia, il Garante alla privacy e l’orientamento della giurisprudenza guidano l’azione della giustizia. Ma non basta: non esiste una legge ad hoc che fissi confini certi nell’era digitale. Solo l’Unione Europea pone qualche paletto.
Tra i molti interventi che il governo Renzi ha in programma per modernizzare l’Italia, da oggi c’è una priorità: fermare questa vergogna. Siamo convinti che Tiziana si potesse salvare. Che almeno il suo sacrificio non sia stato inutile.
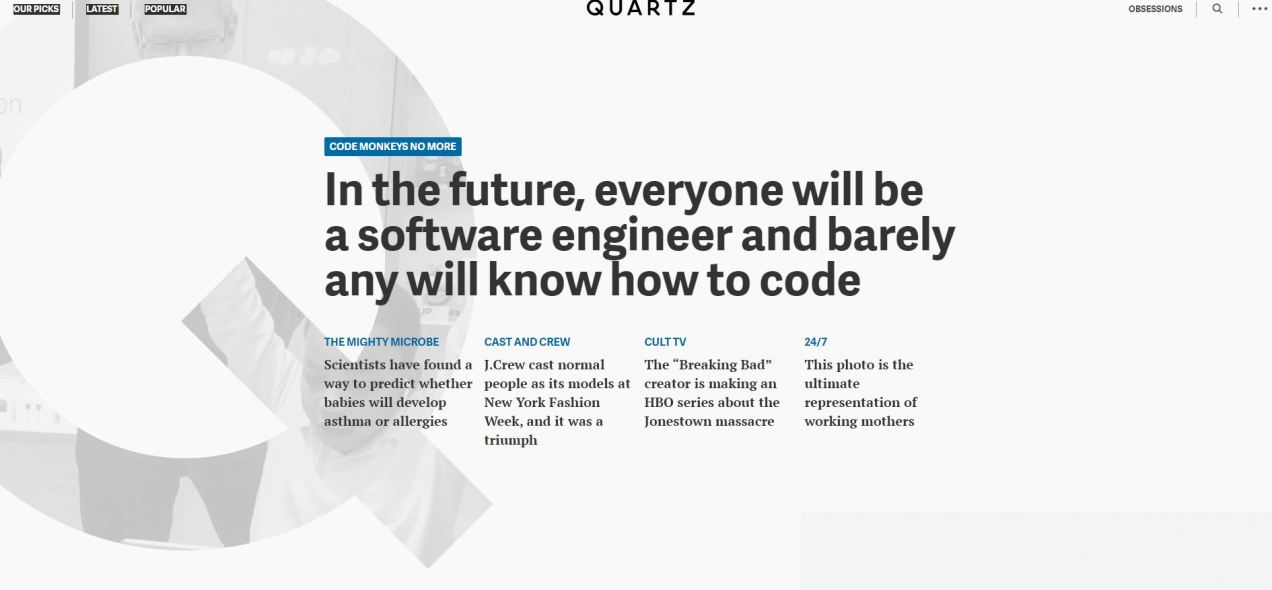
Gli online magazine del millennio
Navigando sul web, mi capita sempre più spesso di trovare siti veramente ben fatti (l’ultimo? Eccolo), sia dal punto di vista grafico che da quello dei contenuti. Ho le sensazione che, finalmente, l’informazione su internet sia arrivata all’inizio di quella che potremmo definire la fase di maturità. Quando ho cominciato a lavorarci (era il 2005), le cose erano molto diverse. Venivo dalla carta stampata, ma mi era chiaro che ero arrivato tardi: in redazione c’era la fila di colleghi di mezza età alla ricerca di un posto fisso e di una sistemazione, e il mio turno sarebbe venuto (ammesso che arrivasse) molto più avanti. Nel frattempo? Il niente. La solita gavetta fatta scrivendo due pezzi a settimana, senza vivere quella pressione che, poi, è la differenza tra un vero giornalista e chi, semplicemente, scribacchia. Non importa si tratti di un mensile o di un quotidiano: se non sai farlo in fretta, non sei del mestiere. E questo si impara solo in redazione.
Insomma, mi serviva un posto dove fare pratica. Mi buttai sul web, prima con un blog, poi con un sito, assieme ad altri giovani. Si chiamava “GiraMi”, ed era in anticipo sui tempi, troppo. Ricordo quando demmo tra i primi la notizia di una svolta sulla congestion charge, la soddisfazione di vedersi in cima a Google News. Poi, raccontavi di lavorare in un giornale online, e la gente ti guardava con compassione. Sostanzialmente, la percezione di affidabilità era pari a zero.
La gente, semplicemente, il web lo ignorava. Tutto qui.
Il problema, visto a posteriori, stava in questi termini: i giornalisti migliori, quelli di esperienza, stavano sul cartaceo. Non sapevano neanche cosa fosse un pc, abituati a macchine con autista e redazioni in cui la catena delle notizie comprendeva fotografi, grafici, impaginatori, correttori di bozze. I giovani, quelli che sapevano usare il web, non avevano abbastanza esperienza e capacità per fare giornali di qualità.In genere avevano tra i 20 e i 25 anni, e a quell’età possono non mancare gli strumenti tecnici e la cultura; ma mancano cose fondamentali: il buonsenso e l’esperienza, che ti porta a fare confronti e a valutare i fatti.
Undici anni dopo, nel 2016, quei giovani sono diventati uomini di mezza età. Qualcuno (molti) ha cambiato mestiere per disperazione, e ne ho visti diversi gettare via il talento senza scrivere più una riga. Altri si sono intestarditi, e ancora annaspano tra collaborazioni miserrime, convinti, come sono, che oggi si possa vivere solo di giornalismo.
Poi ci sono quelli come me, che hanno deciso di fare altre esperienze, magari si sono immaginati una vita diversa, per tornare sui propri passi, perché al cuor non si comanda (ma nel frattempo hanno girato un po’ il mondo, imparato a fare altro, e se ne sono appassionati, anche).
Risultato? Oggi quei trentacinquenni sono grafici, web designer, webmaster, videomaker, insomma, tutto quello che serve per mettere insieme un prodotto qualitativamente valido e, possibilmente, se non di successo, almeno di nicchia. Lavorano tutti sul web, e il web è chiaramente nei loro orizzonti: non più un ripiego, ma scelta nativa, per le possibilità che offre. In più, hanno l’esperienza per scrivere contenuti di qualità, scattare foto appaganti, produrre video significativi.
Oggi esiste una quantità di online magazine che offrono proposte eccezionali per valore di testo e grafica: le news di attualità è sempre meglio pagarle (opinione mia) ma, sulle nicchie, c’è veramente di che leggere. E tutto gratis.
Chissà cosa ci riserva il futuro. La carta resterà per i feticisti della pagina, ma il web sta arrivando a maturazione e le nuove tecnologie propongono sempre maggiore integrazione. Credo si possa dire, a questo punto, che abbiamo veramente svoltato.

Epatite C, la UE e lo strapotere delle lobby
L’articolo che segue è stato pubblicato su TiSOStengo a questo link.
Un nuovo farmaco contro l’epatite C promette l’eradicazione del virus in una percentuale attorno al 90% dei casi. Certo, non significa guarigione per tutti (se c’è cirrosi conclamata, il danno strutturale non è riparabile): ma, se non altro, si impedisce l’evoluzione della malattia. C’è, però, un problema: il farmaco costa tanto, troppo.
L’anno scorso sono stati spesi, in Italia, 1.7 mld di euro per curare 31.069 ammalati (fonte: elaborazione su dati AIFA). Il trattamento per il virus nel nostro paese costa 55.000 euro a paziente.
QUESTIONE DI PREZZO – Si ripropone la questione del prezzo dei medicinali. La Gilead, azienda californiana che produce il preparato in questione (Sovaldi), è infatti in grado di contrattare con le varie agenzie nazionali del farmaco condizioni di vendita più che favorevoli.
Funziona così: dal punto di vista dell’azienda che produce un bene necessario (ad esempio, il farmaco per l’epatite C, ma anche i pannoloni per gli incontinenti, per restare in ambito sanitario), un mercato frammentato è quanto di più desiderabile. Se al tavolo delle contrattazioni si siedono soggetti relativamente piccoli (come le agenzie del farmaco dei singoli paesi), la negoziazione sarà a senso unico: l’ideale per un’azienda farmaceutica che mira al massimo profitto (ricordiamo che, in fondo, si tratta di business, e l’etica c’entra poco). Le trattative, tra l’altro, sono per lo più segrete.
Ma cosa accadrebbe se la contrattazione fosse concordata a livello sovranazionale, diciamo europeo?
Probabilmente, quello a cui si assiste per un altro bene “di prima necessità” , i già citati pannoloni: prezzi più bassi se lo Stato ne acquista centralmente grandi quantità, distribuendole tramite il sistema sanitario. Nella Ue esiste senz’altro la possibilità di centralizzare le decisioni di acquisto. Basta trovare l’accordo.
IL PROBLEMA DI STIMOLARE LA RICERCA – Tutto risolto, quindi? Non proprio. Anche Big Pharma ha le sue buone ragioni (ne avevamo parlato qui): prezzi troppo bassi significano perdere lo stimolo per la ricerca e, quindi, ogni incentivo allo sviluppo di nuove terapie. Cerchiamo di spiegarci.
In pratica, per come è strutturato il settore, nessuno investe in ricerca su farmaci che, nel lungo periodo, non hanno il potenziale di ripianare i costi. E dato che, fra le tante molecole testate, sono poche quelle che superano le severe fasi disperimentazione, è solo ed esclusivamente da quelle capaci di arrivare in commercio che le aziende dipendono per tenere in piedi i bilanci e fare utili. Le altre rappresentano perdite secche. Un esempio evidente del meccanismo sono i farmaci orfani (leggi qui), quelli che curano malattie poco diffuse: fare ricerca in questo campo non conviene a nessuno perché manca un mercato sufficientemente ampio. Con tutto quello che ne consegue nei termini di un diritto alla salute che cessa di essere universale.
TRASPARENZA ZERO – Ci si addentra in un terreno estremamente scivoloso che dall’economia declina verso la politica. Se le aziende ragionano in base ai bilanci e alle logiche di mercato (e non potrebbe essere altrimenti), spetta ai governi intervenire con correttivi utili ad aggiustare i prezzi, badando però a non azzerare lo stimolo che porta ad assumersi il rischio di impresa.
In concreto, sono due le strade che gli Stati impiegano per incentivare le aziende a investire: ricorrere ad aiuti diretti oppure fornire agevolazioni indirette come, ad esempio, sgravi fiscali (probabilmente un’opzione migliore).
Ma c’è una terza arma, probabilmente ancora più efficace: la trasparenza, e una regolamentazione vera delle lobby. Che, a Bruxelles, sono da sempre un’istituzione parallela. Stazionano nei palazzi del potere, preparando comodi riassunti (ovviamente interessati) sulle questioni del giorno, ad uso di parlamentari che di farmacologia non masticano più di quanto si intendano di fiscalità internazionale o dimensione delle olive.
Se poi ai bignami si accompagna la “riconoscenza” dell’industria, e Big Pharma sa essere munifica, si comprende come mai, a tutti i livelli, sulle lobby si preferisca non decidere. Ma quanto converrebbe portare tutto alla luce del sole, come qualche forza politica (ad esempio i Cinque Stelle) chiede a ragione?
Guglielmo Pepe su Repubblica ricorda che per trattare tutti i malati – gravi e meno gravi – di epatite C nel nostro paese servirebbero 8 miliardi di euro l’anno, pari circa alla metà di una finanziaria di media portata. Una cifra da spendere da qui al 2025, cui va aggiunto il resto della spesa farmaceutica. Certo, si tratta di un investimento. Ma sedersi al tavolo delle contrattazioni nella maniera migliore per spuntare un prezzo equo è quanto farebbe ogni “buon padre di famiglia” recandosi al mercato. E quindi, anche ciò che dovrebbe fare l’Europa

